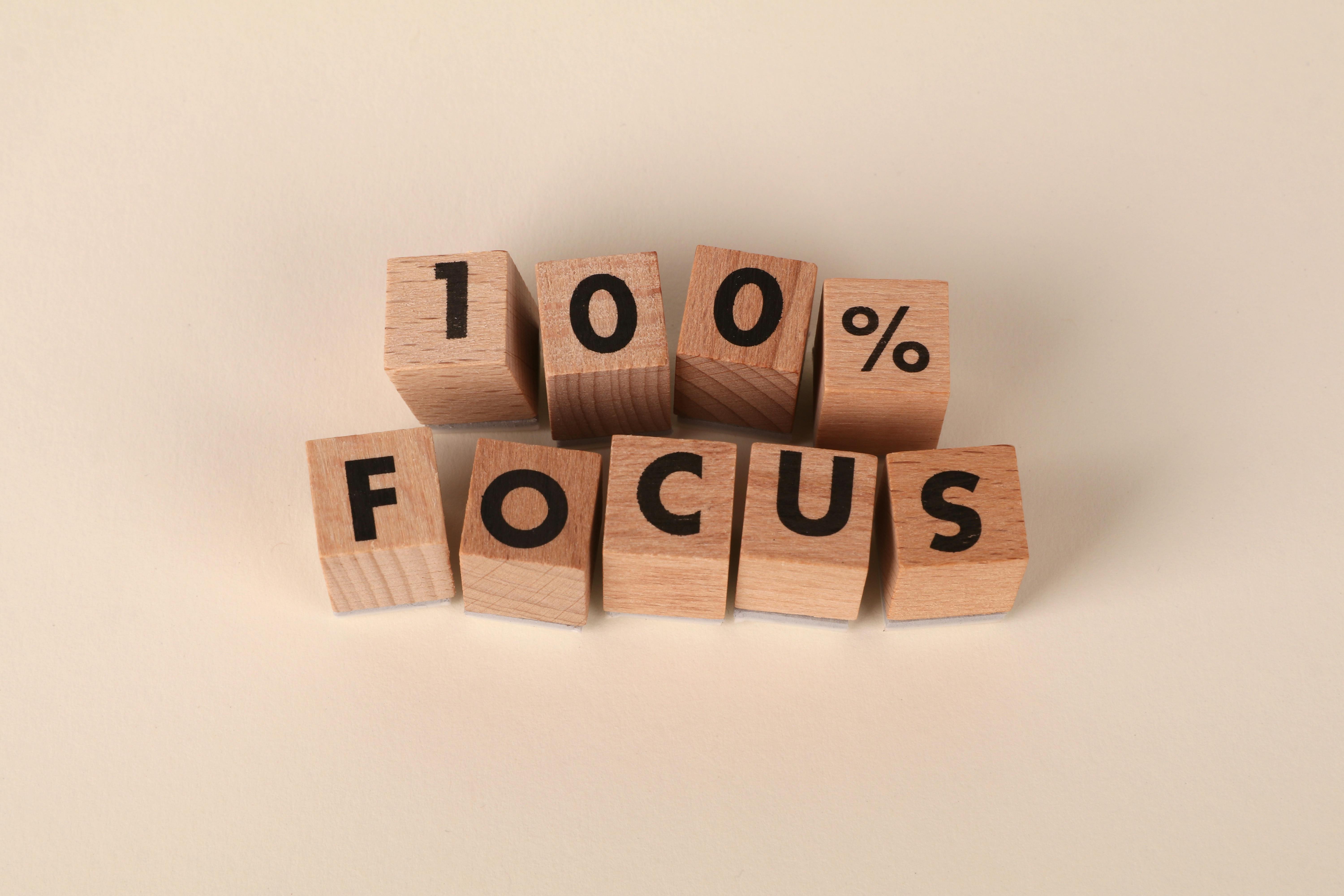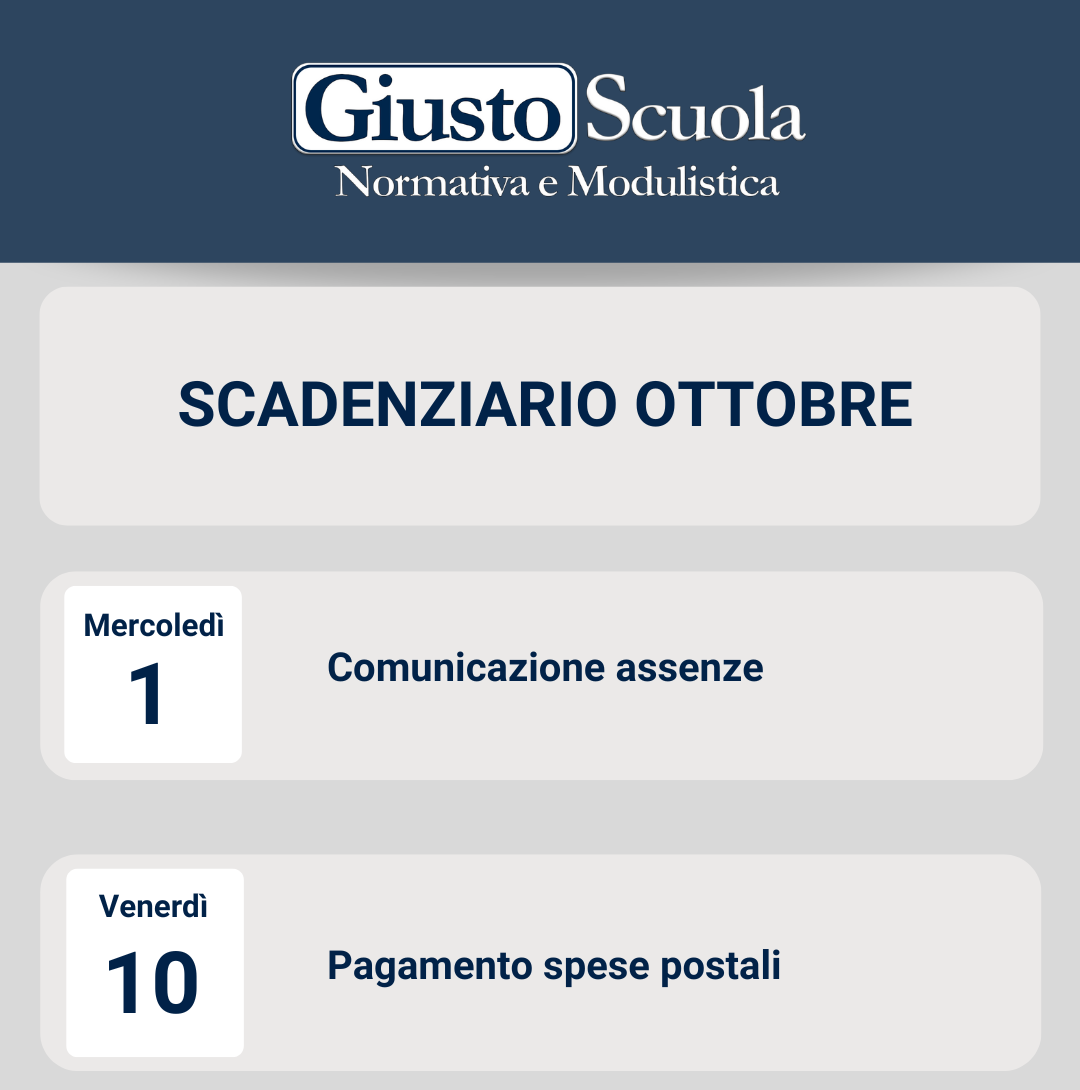A causa di un diverbio continuo e imperterrito tra due ATA, sono cominciate ad arrivarmi richieste di trasferimento per incompatibilità ambientale nonché segnalazioni sul fatto che alcune condotte, ritenute persecutorie sono ascrivibili al mobbing. Oltre al procedimento disciplinare da instaurare chiedo gentilmente come posso valutare l'assumibilità di tali comportamenti per danni derivanti da mobbing.
Risposta
Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo, ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost., che devono conformare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro.
Secondo la consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
L'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
A tal fine, la legittimità dei provvedimenti può rilevare ma solo indirettamente perché, ove facciano difetto elementi probatori di segno contrario, può essere sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata; parimenti la conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore.
Nel giudizio sulla sussistenza o meno dell'intento persecutorio rileva anche la natura pubblica del datore di lavoro, che, nel rispetto del principio costituzionale del “buon andamento” consacrato nell’art. 97 Cost., è tenuto ad intervenire per assicurare efficienza, legittimità e trasparenza dell'azione amministrativa.
Se la fattispecie del mobbing è ormai risalente, sempre di creazione giurisprudenziale, ma più recente, è l’istituto dello straining.
Quest'ultimo è stato per la prima volta definito in sede giudiziaria dal Tribunale di Bergamo (Trib. Bergamo 20 giugno 2005, n. 286) come «situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente di lavoro, azione che oltre ad essere in sé stressante» è altresì caratterizzata «da una durata costante» ed idonea a porre chi la riceve «rispetto alla persona che attua lo straining, in persistente inferiorità».
Come poi precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18164/2018; Cass. ord. n. 3977/2018), lo straining, è considerato una forma attenuata di mobbing.
Ad integrare lo straining, infatti, sono sufficienti «comportamenti stressogeni che producono effetti dannosi permanenti nel tempo, scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità di azioni vessatorie [...] o esse siano limitate nel numero [...] e distanziate nel tempo» (Cass. n. 15159/2019), potendosi anche ridurre ad una condotta isolata.
Va, invece, escluso lo straining in presenza di "situazioni di amarezza", causate dal cambio di posizione lavorativa per processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda (Cass. n. 2676 del 2021), né sono ravvisabili ragioni di responsabilità in un caso di divergenza interpersonale sul luogo di lavoro che non configuri, come tale, una situazione di nocività dell'ambiente lavorativo (Cass. n. 24339 del 2022).
Se nel mobbing va dimostrato, anche nella forma della prova indiziaria, l’intento persecutorio, nello straining il lavoratore è esonerato dalla prova di tale intento, in quanto l'adozione da parte del datore di lavoro di condizioni “stressogene” è di per sé rilevante e prescinde dall'intenzionalità.
Entrambe le nozioni sono mutuate dalla scienza medico-legale e funzionali all'individuazione di comportamenti lesivi di interessi costituzionalmente protetti ed integranti una violazione dell'art. 2087 c.c., norma che, per pacifica interpretazione, ha una funzione prevenzionale e quindi delinea i contorni dell'obbligo di sicurezza che incombe sul datore di lavoro, facendo conseguentemente sorgere una responsabilità contrattuale in capo allo stesso.