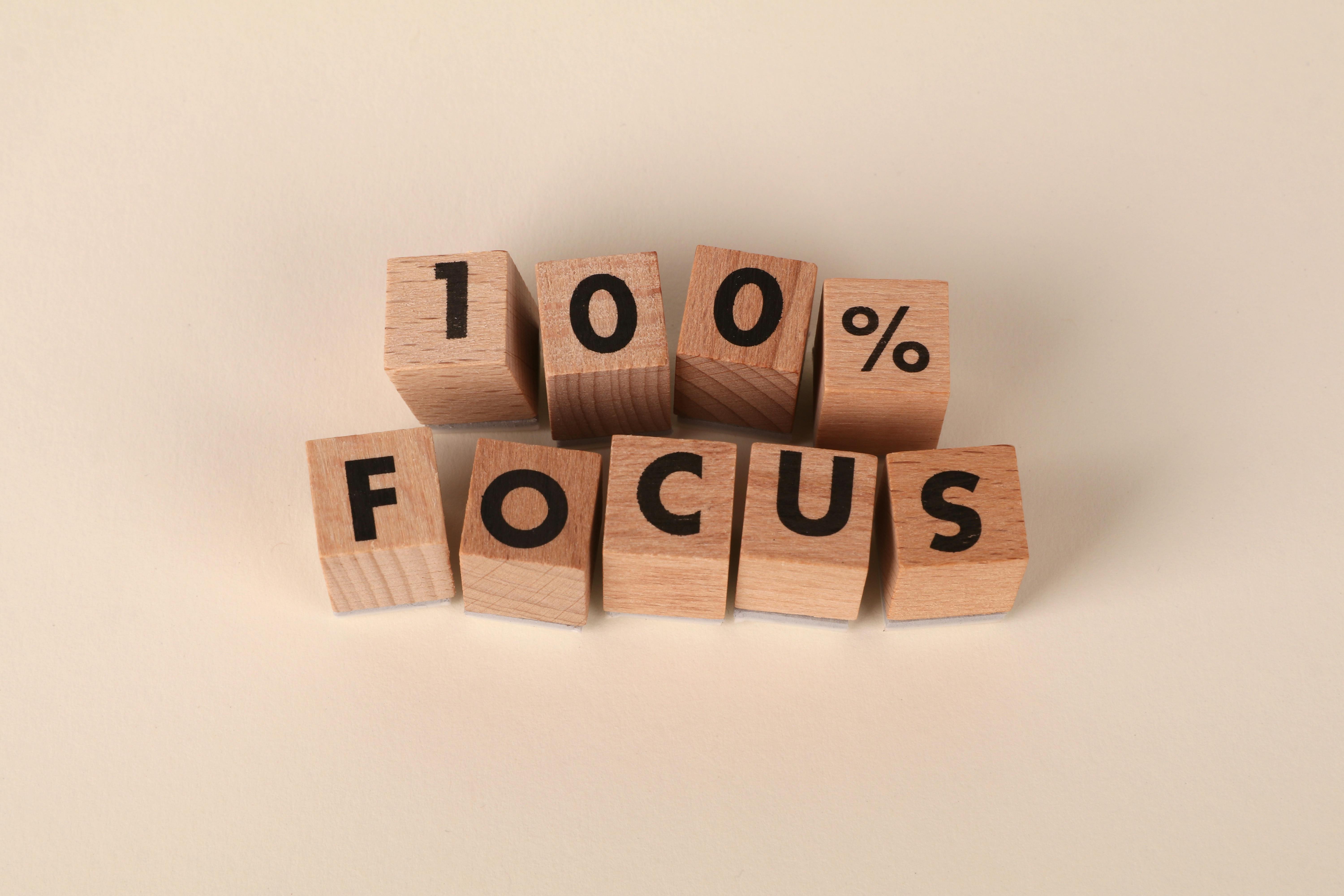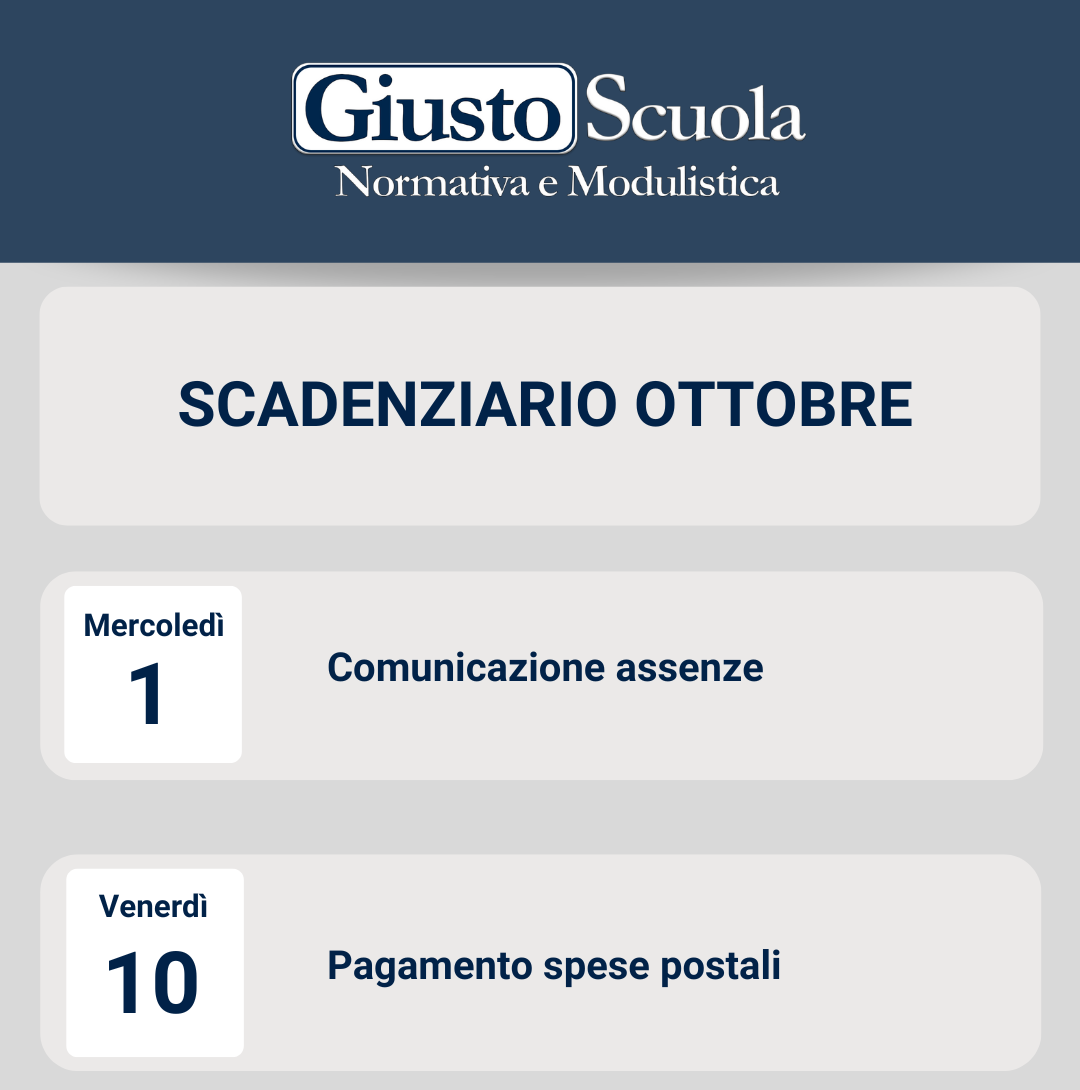Ad una collaboratrice scolastica, a causa di una situazione estremamente stressante, viene trasmesso certificato di malattia per un mese. Il certificato consisteva in "Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio". A distanza di poche settimane, ricevo un parere legale da parte sua, intimando il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, dovuto a situazioni lavorative conflittuali e stressogene (ossia mobbing e straining) senza però corrobare quali iniziative e comportamenti avrebbero in concreto causato tali ipotesi. In che modo posso argomentare una mia posizione ? Premesso che ho cercato con tale soluzione del certificato di malattia per causa di servizio di venire in contro alla dipendente e non certamente "dare atto" di una situazione di incompatibilità tra me e lei. Grazie della disponibilità.
Risposta
La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e non rivestono, almeno per il momento, autonoma rilevanza ai fini giuridici, essendo impiegate al solo fine di identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l’art. 2087 del codice civile e la disciplina vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quanto al mobbing un consolidato indiritto interpretativo consolidato ha indicato elementi costitutivi configurandolo quando:
-
con intento vessatorio e in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo, siano posti in essere contro il lavoratore una serie di comportamenti, illeciti o anche leciti, se considerati singolarmente, aventi carattere persecutorio;
-
sia realizzato un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del lavoratore;
-
sia accertata l’esistenza di un nesso eziologico tra la condotta avente carattere persecutorio e il pregiudizio subìto dal lavoratore nella propria integrità psicofisica o dignità;
-
sia rilevato l’intento persecutorio (elemento soggettivo), unificante le condotte lesive.
L’elemento qualificante la fattispecie deve essere dunque ricercato nell’intento persecutorio che avvince la pluralità delle condotte pregiudizievoli, a prescindere, come detto, dalla legittimità o illegittimità dei singoli atti, «in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime». Il Testo unificato definisce a sua volta il mobbing come «atti di minaccia o molestia compiuti da parte di datori di lavoro, capi intermedi, colleghi di pari grado o di grado inferiore, che, per la loro intensità, frequenza o durata, ingenerano nel lavoratore un grave stato di ansia e/o paura tale da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita».
Peraltro secondo il disposto di cui all’art. 2, c. 2 del Testo unificato recante Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo, adottato l’11 maggio 2022 dalla XI Commissione permanente Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, gli atti che integrerebbero in concreto la fattispecie di mobbing sono, a mero titolo esemplificativo:
a) il ridimensionamento del ruolo, dei compiti e delle responsabilità, senza comprovate ragioni organizzative o produttive;
b) il sabotaggio sistematico dell’attività di lavoro attuato mediante lo svuotamento delle mansioni e la privazione degli strumenti necessari al suo svolgimento;
c) il comprovato abuso del potere direttivo o disciplinare da parte del datore di lavoro o dei dirigenti, posto in essere tramite reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni disciplinari ingiustificate, predisposizione di orari o turni di lavoro penalizzanti;
d) il rifiuto di permessi, ferie o trasferimenti senza comprovate ragioni organizzative o produttive;
e) la delegittimazione della professionalità e/o pregiudizio delle prospettive di carriera;
f) l’immotivata esclusione o marginalizzazione dall’attività lavorativa, ivi compresa l’esclusione dalle comunicazioni e informazioni aziendale.
Quanto allo straining è stata elaborata una nozione ritenuta "attenuata" di mobbing, configurabile anche quando non sia rilevato l’elemento della continuità delle azioni vessatorie, in quanto la condotta nociva può realizzarsi anche con un’unica azione isolata ovvero con più azioni prive di continuità temporale che determinino, con efficienza causale, una situazione di stress lavorativo e conseguenti gravi disturbi psico-somatici, psico-fisici o psichici.
Il Testo unificato pare recepire anche la "variante colposa" della fattispecie di straining, definito appunto quale condotta posta in essere dal datore di lavoro, capi intermedi, colleghi di pari grado o di grado inferiore e generatrice uno stato di stress, determinato da disfunzioni degli assetti organizzativi aziendali «tali da ingenerare nel lavoratore forme di pressione psicofisica superiore a quella connaturata alla natura stessa del lavoro o dell’attività svolta e che sono idonee a causare, anche indirettamente, una lesione dell’integrità psicofisica dello stesso lavoratore».
Non integrano gli estremi dello straining le pur accese divergenze lavorative o le situazioni di normale conflittualità tipiche di ogni teatro lavorativo. Sin tanto che non si sviluppi in condotte vessatorie rispetto alle quali il lavoratore risulti incapace di difendersi in modo adeguato, una situazione di disagio lavorativo non è infatti di per sé un elemento decisivo ai fini dell’accertamento dello straining, configurabile quando sia dimostrata l’esorbitanza «nei modi per la gestione del conflitto interpersonale». Infatti, «forti divergenze sul luogo di lavoro come tali non intercettano una situazione di nocività, perché il rapporto interpersonale, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa (…), è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può dirsi, se non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano» sì da comportare la violazione dell’art. 2087 del codice civile.
Dunque come statuito dalla Corte di Cassazione, "Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione" (Cass. civ., sez. lav., 26 aprile 2017, n. 10319).
Deve ritenersi pertanto che Il mero riconoscimento della causa di servizio non comporta una automatica responsabilità del datore di lavoro, ascribile né allo straining e nemmeno al mobbing.