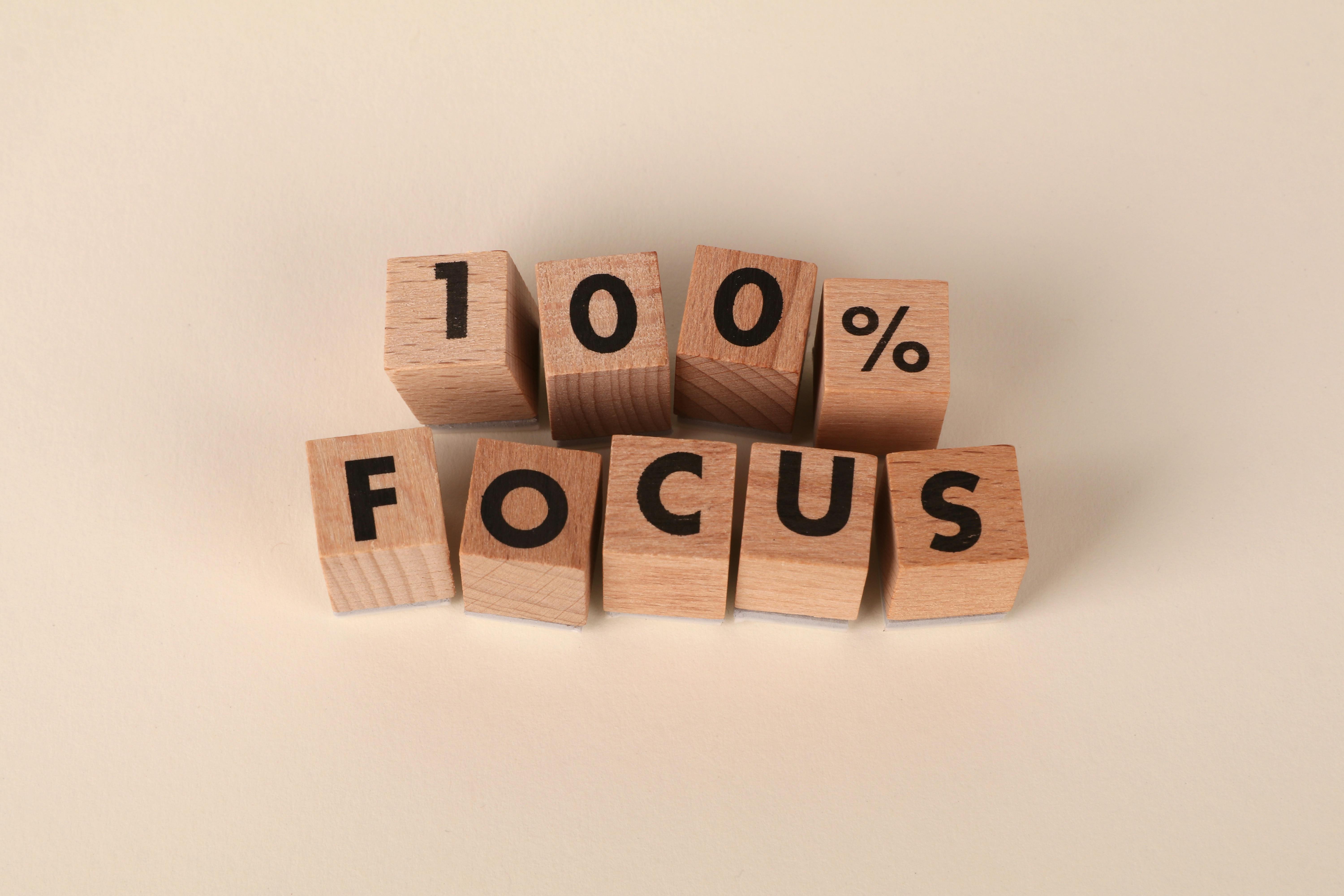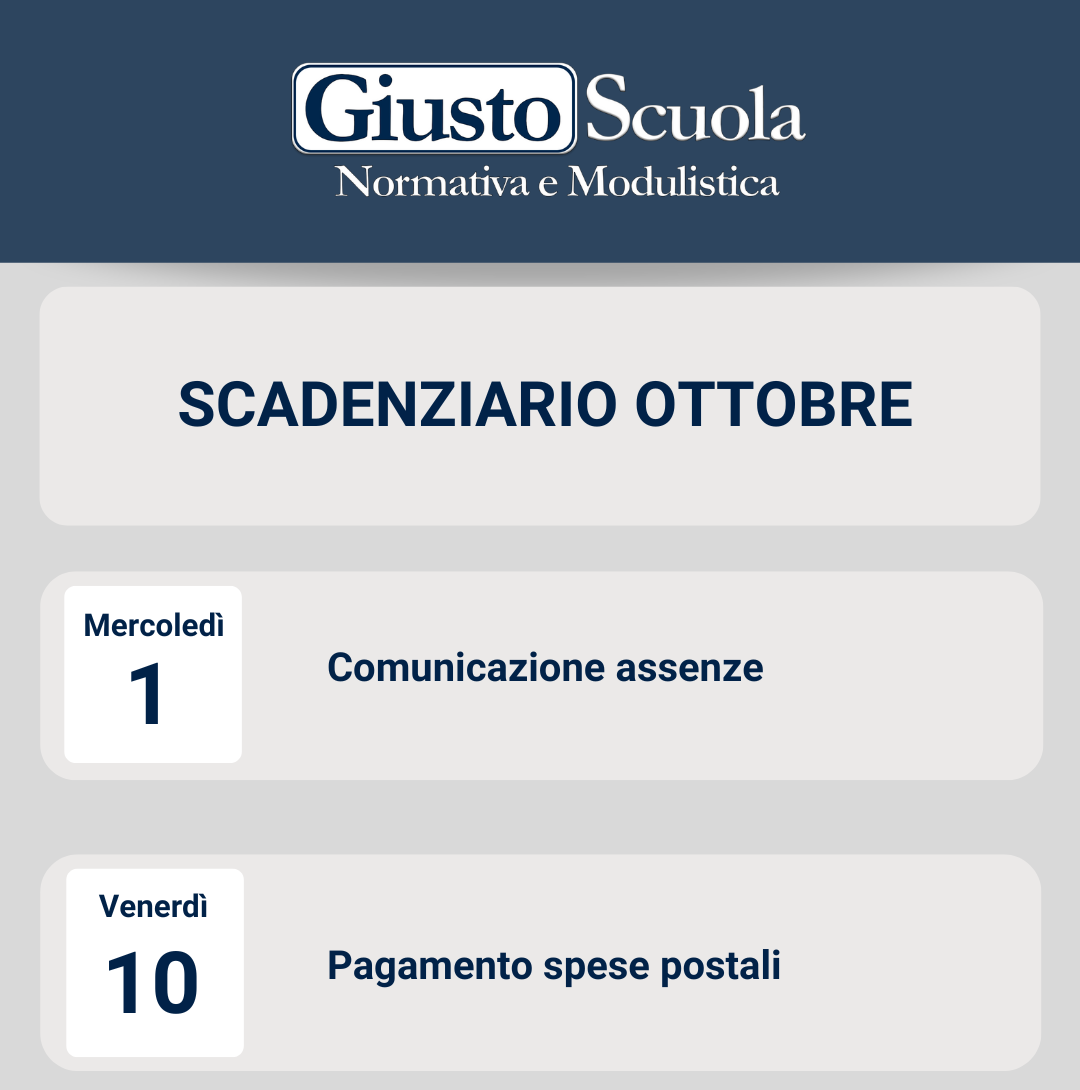Gli organi collegiali della scuola esprimono la loro volontà attraverso la deliberazione. Non bisogna dimenticare che nella scuola autonoma, la rilevanza delle decisioni assunte, con riferimento all’attività istituzionale, è di notevole entità, poiché sostanzia quello spazio di discrezionalità portato, appunto dall’attribuzione dell’autonomia. Non v’è dubbio che al governo della scuola sono prepostitre soggetti, il consiglio, il collegio dei docenti e il dirigente, ognuno dei quali svolge funzioni diverse, ma tutti e tre concorrono a mettere in azione la volontà dell’istituzione. Mentre il dirigente pone in essere atti amministrativi o di carattere civilistico, gli organi collegiali devono formare e successivamente esplicitare la loro volontà attraverso il procedimento deliberativo.
Con riferimento alla scuola accenniamo alla funzione dirigenziale di dare esecuzione alle delibere degli organi collegiali.
Dal punto di vista dommatico, ponendo attenzione al procedimento di formazione dell’atto collegiale, la deliberazione è stata intesa, innanzitutto, come la “fase dell’iter di formazione dell’atto collegiale…in cui si determina il contenuto di esso”, sia facendo riferimento alla successione delle fasi del procedimento, sia alla funzione di “unificazione della volontà dei membri del collegio o di meccanismo di imputazione al collegio della volontà di una parte di questi membri”.
Ma la deliberazione, sia come modalità collegiale di formazione di un atto, sia come atto collegiale, costituisce un unicum visto in itinere o nel risultato. Vista come procedimento, la deliberazione costituisce l’iter di formazione dell’atto collegiale nella quale si determina il suo contenuto. Il procedimento consta di quattro fasi: proposta, discussione, voto, proclamazione. Una volta insediato formalmente il collegio, il presidente che ha la funzione di dirigere i lavori, sottopone al collegio i singoli argomenti posti all’ordine del giorno, secondo l’ordine stabilito. Degli argomenti ogni singolo componente dovrebbe essere già a conoscenza. Nell’istituzione scolastica la complessità delle attività e la complessità strutturale degli organi collegiali richiederebbero una predisposizione del flusso decisionale strutturata in modo tale da addivenire in tempi contenuti alla conclusione dell’iter. Molte scuole utilizzano già una pre-informazione ai componenti l’organo collegiale sulle tematiche oggetto di trattazione, sulle quali ognuno si esprime in anticipo e permette al presidente di trarne conclusioni ed orientamenti nella proposta decisionale.
Su ogni punto di discussione il presidente o un altro membro dell’organo collegiale presenta una sua proposta di deliberazione sulla quale si apre la discussione. Ciascun componente può prendere la parola ed esprimere il suo parere, ma può anche avvenire che la discussione preceda la proposta di deliberazione. Per la regolazione temporale della discussione si può fissare un termine regolamentare; in caso contrario è il presidente che, considerata esaurita la discussione e sufficiente ai fini della maturazione della volontà collegiale, la dichiara conclusa e mette ai voti la proposta. Nel caso in cui le proposte siano più d’una egli stabilisce un ordine secondo criteri obiettivi. Sullo stesso ordine, nel caso non via accordo, il dirigente può far esprimere l’organo collegiale.
Su ogni singola proposta ogni membro dell’organo collegiale esprimerà il proprio voto palese o segreto secondo le disposizioni di legge; in mancanza secondo quanto stabilito dal presidente e in caso di disaccordo secondo quanto stabilito dallo stesso organo con voto palese. A scrutinio segreto vanno adottate le deliberazioni che riguardano persone30.. La proposta si struttura in deliberazione dell’organo collegiale dopo l’espressione favorevole dei membri presenti, nel numero previsto dalle disposizioni normative che è variabile secondo del tipo di organo collegiale della deliberazione da adottare. Si tratta del quorum funzionale.
Nell’istituzione scolastica la norma di riferimento per il procedimento deliberativo è l’art. 37 TU (d.lgs n. 297/94). Al comma due, ai fini della valida costituzione dell’organo collegiale, è previsto che “Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica”.
Il comma successivo prevede il quorum funzionale “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”.
Durante la votazione i membri possono astenersi dall’esprimere il proprio voto. Normalmente il membro astenuto è considerato assente in quel momento della seduta collegiale, pertanto non viene computato tra i votanti. In questo caso, va modificato, ove possibile il quorum funzionale. Nel caso sia richiesta, per quel tipo di votazione, la maggioranza assoluta, l’astensione non è ammessa. Ciò dà conto della non ammissione dell’astensione nei collegi perfetti.
Nell’istituzione scolastica, in particolare nel collegio dei docenti, l’aspetto dell’astensione è molto delicato poiché non si tratta di decisioni che investono l’amministrazione scolastica strictusensu, ma hanno contenuti di natura tecnico professionale. Ciò non rende giustizia dell’astensione in un contesto di professional che devono avere a cuore la mission educativa e formativa dell’allievo. Un accordo professionale potrebbe regolare l’uso dello strumento dell’astensione che non dà conto di posizioni tecnico professionali che dovrebbero costituire l’ossatura motivazionale del collegio.
I lavori dell’organo collegiale si svolgono alla presenza esclusivamente dei membri del collegio. La presenza di estranei vizierebbe nella legittimità la deliberazione, a meno che di persone che svolgono attività servente, burocratica e tecnica. Pensiamo, nella scuola, al direttore sga che partecipa ad un collegio dei docenti, o ad un rappresentante dell’ente locale che partecipa ad un consiglio di istituto.
L’attività collegiale va verbalizzata a cura di un membro del l’organo collegiale appositamente designato come segretario, attraverso la descrizione della discussione; trascrive integralmente il contenuto letterale di ciascuna deliberazione così come si è formata. Negli organi collegiali il verbale produce certezza pubblica; da qui la responsabilità del segretario.
Nella scuola la verbalizzazione viene richiamata nel CCNL 1998-2000, art. 10, che dà indicazioni sulle modalità di verbalizzare le attività degli organi collegiali. Dice, infatti, il secondo comma “Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa”.
Certamente la volontà delle parti da mettere in rilievo è l’aderenza ai principi della trasparenza, prima, e della semplificazione, poi. “Il limite strettamente indispensabile” va subordinato all’osservanza dei due principi prima enunciati. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito ed ha rilevato che nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un organo collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti nella discussione, essendo sufficiente che siano riportate, anche in maniera stringata e sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute).
Spesso qualcuno eccepisce la discrasia tra l’adunanza e il momento dell’approvazione del verbale, che solitamente viene redatto tra una seduta e l’altra dell’organo collegiale scolastico. E da riconoscere la legittimità della redazione di un processo verbale sulla scorta di appunti trascritti nel corso di una seduta, redatto successivamente è importante che nella verbalizzazione risultino chiari gli elementi che consentono di affermare che la decisione è stata assunta secondo le prescrizioni normative.
Ma l’aspetto più interessante all’interno del procedimento di formazione della volontà è senz’altro rappresentato dai meccanismi di fusione delle singole volontà in un’unica volontà e di imputazione di essa all’organo collegiale. Come afferma lo stesso Nigro, questa fusione rimane un mistero. Alcuni autori, in dottrina, distinguono il processo di fusione e imputazione della volontà collegiale in due fasi: la prima costituita dalla formazione della volontà della maggioranza, la seconda dalla formazione della volontà del collegio. La deliberazione viene considerata come la prima tappa che si conclude con la formazione della volontà di maggioranza ed è preliminare ed autonoma rispetto alla vera nascita e costituzione dell’atto collegiale, costituito dalla proclamazione del presidente, che costituisce all’esterno la delibera collegiale.