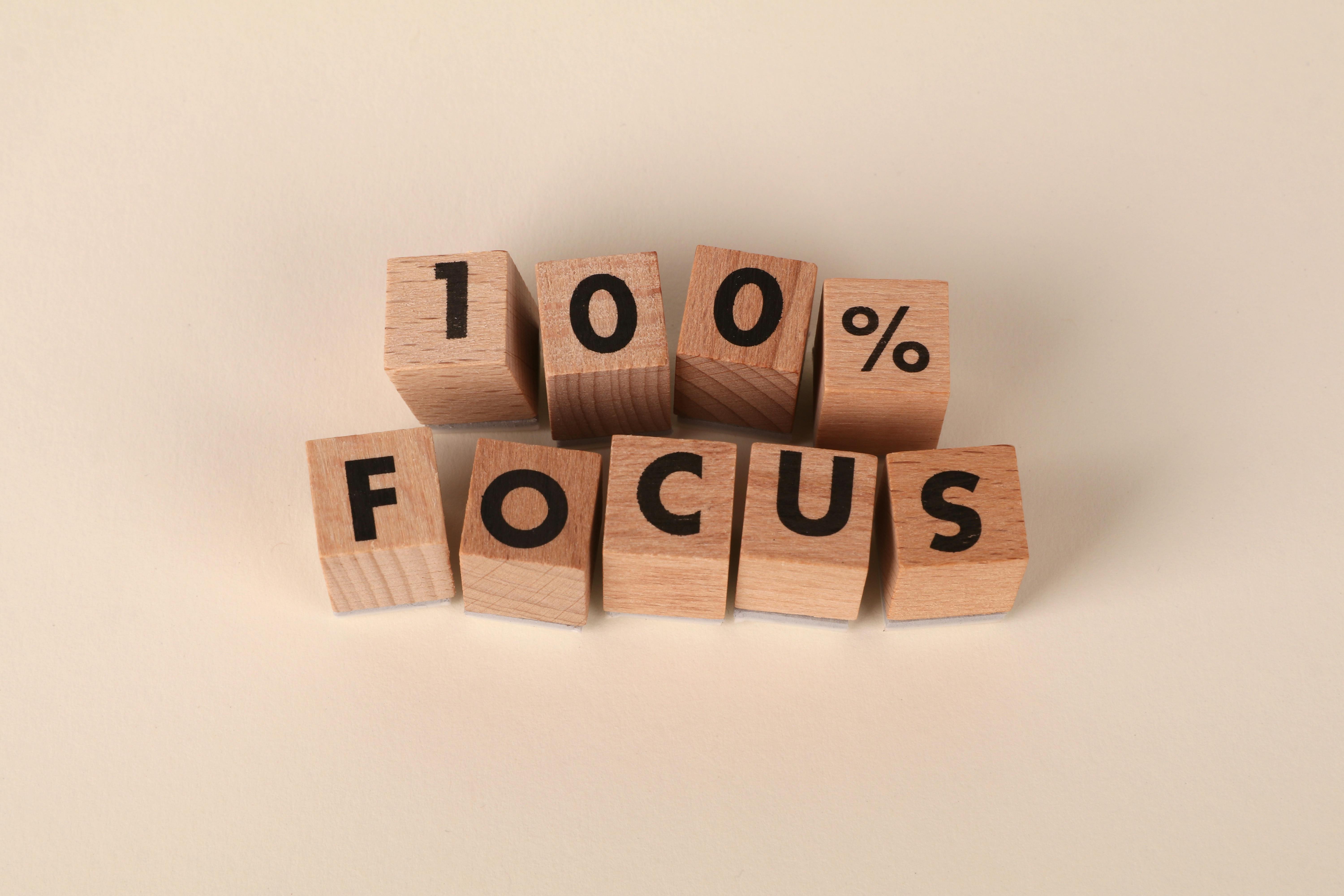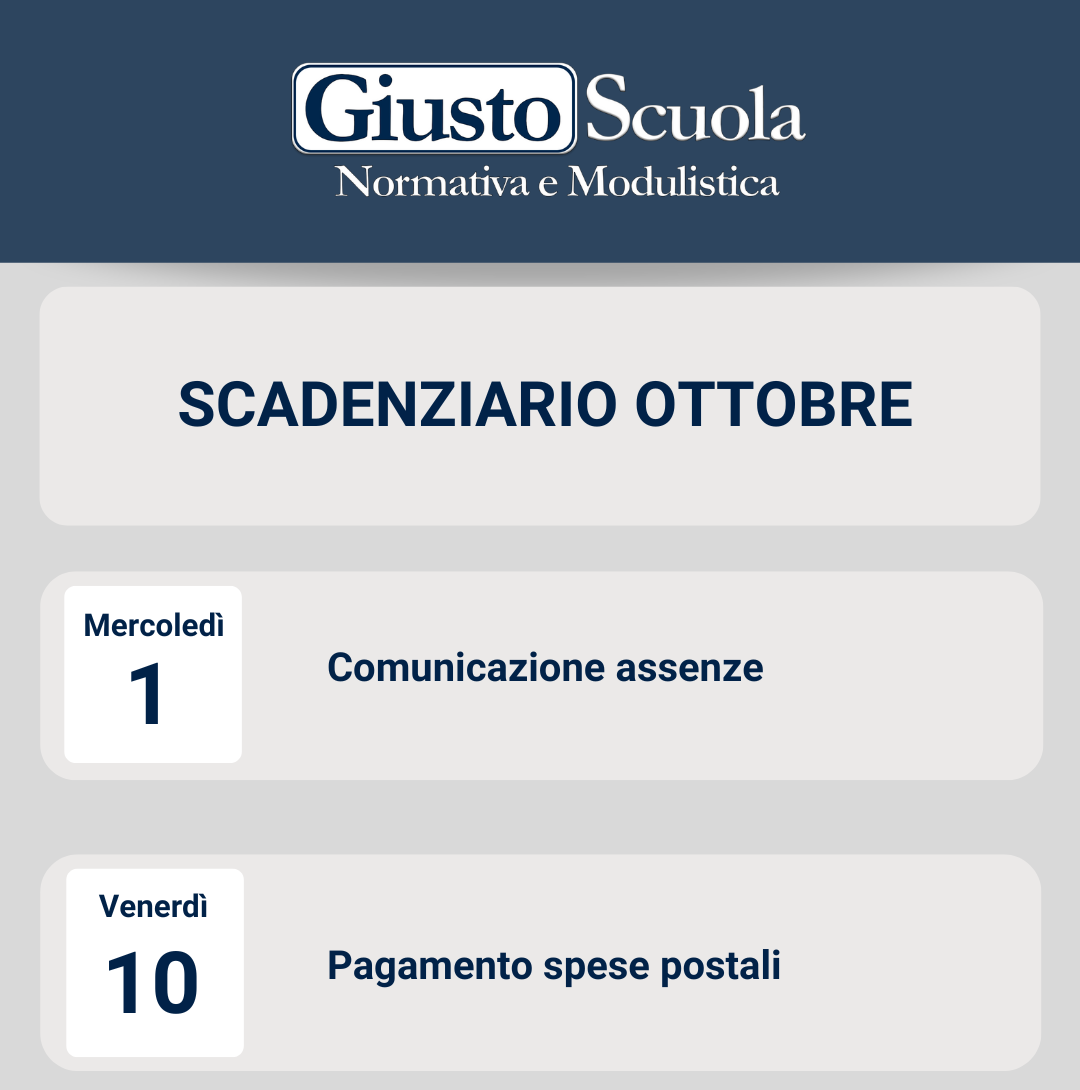Scienza dell'Amministrazione Scolastica 1/2023
Editoriale di Anna Armone
Siamo alle solite. Una sorta di ottusa e sclerotica lettura delle norme porta all’adozione, nel sistema scolastico, di disposizioni che il legislatore ha previsto per modelli assai lontani dalla scuola. Eppure, accade di continuo che nell’applicazione di norme destinate a tutta la pubblica amministrazione la scuola rimanga incastrata in interpretazioni forzate. È accaduto con l’organizzazione del sistema Privacy, con la Trasparenza sul sito web, accade con la rotazione dei dirigenti.
Ad oggi non so come andrà a finire la storia, ma è davvero singolare (eufemismo) leggere l’evoluzione dell’istituto.
È proprio dalle faq dell’Anac che abbiamo la prima risposta “automatica”. Alla domanda “quali enti sono tenuti a dare attuazione alla misura della c.d. rotazione ordinaria? Ecco la risposta “Sono tenuti ad attuare la misura della rotazione ordinaria le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. L’ANAC ha valutato opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l’adozione di misure di rotazione anche per gli enti di diritto privato a controllo pubblico e gli enti pubblici economici, anche se non tenuti per legge all’applicazione della misura”.
“Le ragioni della rotazione sono da riportare all’esigenza di garantire una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.Quanto ai dirigenti, specialmente quelli operanti nelle aree a più elevato rischio corruttivo, l’istituto della rotazione dovrebbe essere una prassi “fisiologica”.
La rotazione del personale è considerata,dunque, quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura fondamentale che il Piano Nazionale Anticorruzione individua e motiva ritenendo che: "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione". L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.
Ma quanto tale modello è necessario e adatto alla dirigenza scolastica? La stessa Anac afferma che “tale misura rappresenta una prassi virtuosa che le Amministrazioni devono perseguire, anche tramite l’utilizzo della formazione finalizzata a rendere interscambiabili i ruoli tra i vari dipendenti. La formazione rappresenta infatti una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione (cfr. all. 2 PNA 2019 § 4). La rotazione, inoltre, deve essere prevista e disciplinata nel Piano ovvero in un diverso atto organizzativo, mediante una programmazione anche pluriennale e rispettosa del criterio di gradualità”. Da questa affermazione si comprende come il modello organizzativo al quale si riferisce la norma è un sistema complesso strutturato su più figure dirigenziali che gestiscono ognuna un servizio con tutte le prerogative che la norma riconosce loro.
Ma, per quanto riguarda la scuola, ulteriori ragioni intervengono sulla dubbia opportunità applicativa dell’istituto. Dirigere un’istituzione scolastica è mestiere al quale si arriva dopo aver attraversato la carriera docente. È così che il dirigente sa interpretare la realtà che lo circonda, sa attivare i processi educativi e garantire la qualità del servizio. La “qualità del servizio” non la legittimità dell’azione amministrativa che rappresenta solo uno dei volti dell’azione della scuola. Il Dirigente è, dunque, un leader educativo perché depositario di compiti di coordinamento, gestione e potenziamento del contesto educativo (Barzanò, 2011); organizzativo perché deve saper lavorare in un'entità organizzativa complessa e caratterizzata da legami sistemici come la scuola; relazionale perché deve gestire gli ambiti delle relazioni interpersonali, dei rapporti interistituzionali, della comunicazione informale e formale; amministrativo perché esercita a tutti gli effetti funzioni pubbliche. E tutto questo dovrebbe garantirlo nell’arco di due incarichi, pari a sei anni. Ma anche se fosse plausibile tale traguardo costituirebbe sempre l’applicazione di uno schema rigido che non si addice ad un’organizzazione che ha come obiettivo di missione l’educazione, la formazione e l’istruzione che non si misurano sulla legittimità formale – questa sì controllabile – che va considerata come strumentale e, in una certa misura, va data per scontata. Significa che un’organizzazione che educa alla legalità deve trovare al suo interno la forma dell’autocontrollo e dell’autocensura dei comportamenti violativi di norme procedurali e comportamentali.
La maladministration in un’istituzione come la scuola non si combatte con le griglie preconfezionale, con lo spostamento delle pedine decisionali. Che l’amministrazione pensi ad altre modalità per evitarla, magari sgravando le scuole da adempimenti farraginosi e burocraticamente ossessivi e affidando gli stessi ad un modulo operativo collocato sul territorio, considerato che nei processi decisionali della spesa si annida il potenziale corruttivo. In tale contesto si evidenzia che l’importanza della centralizzazione delle procedure di acquisto, risiede nel fatto che essa è in grado di favorire efficacemente la riduzione ed il controllo delle risorse pubbliche impiegate. A sostegno di tali affermazioni vi sono numerosi argomenti, tra i più significativi si segnalano: la realizzazione di economia di scala, la riduzione del numero di entità organizzative coinvolte nell’esercizio delle funzioni amministrative, facendo così diminuire il costo del controllo sulla regolarità formale delle procedure, nonché accrescere l’efficacia dei controlli interni e un’organizzazione più razionale del personale.
La centralizzazione, inoltre, può essere considerata strumento di stimolo per l’innovazione delle imprese che partecipano alle procedure, accentuando la concorrenza e con l’avvento della specifica disciplina in materia di anticorruzione, Legge n. 190/2012, sembra imporsi anche un’altra finalità, quella di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi, in quanto i centri di responsabilità sono più chiaramente individuati. Nel diritto interno, la centralizzazione dei processi di acquisto è stata perseguita anche attraverso la disciplina e la promozione delle centrali di committenza.
Uno sforzo, dunque, necessario e urgente di ripensamento del coinvolgimento automatico della scuola nel calderone dei destinatari della rotazione degli incarichi dirigenziali.