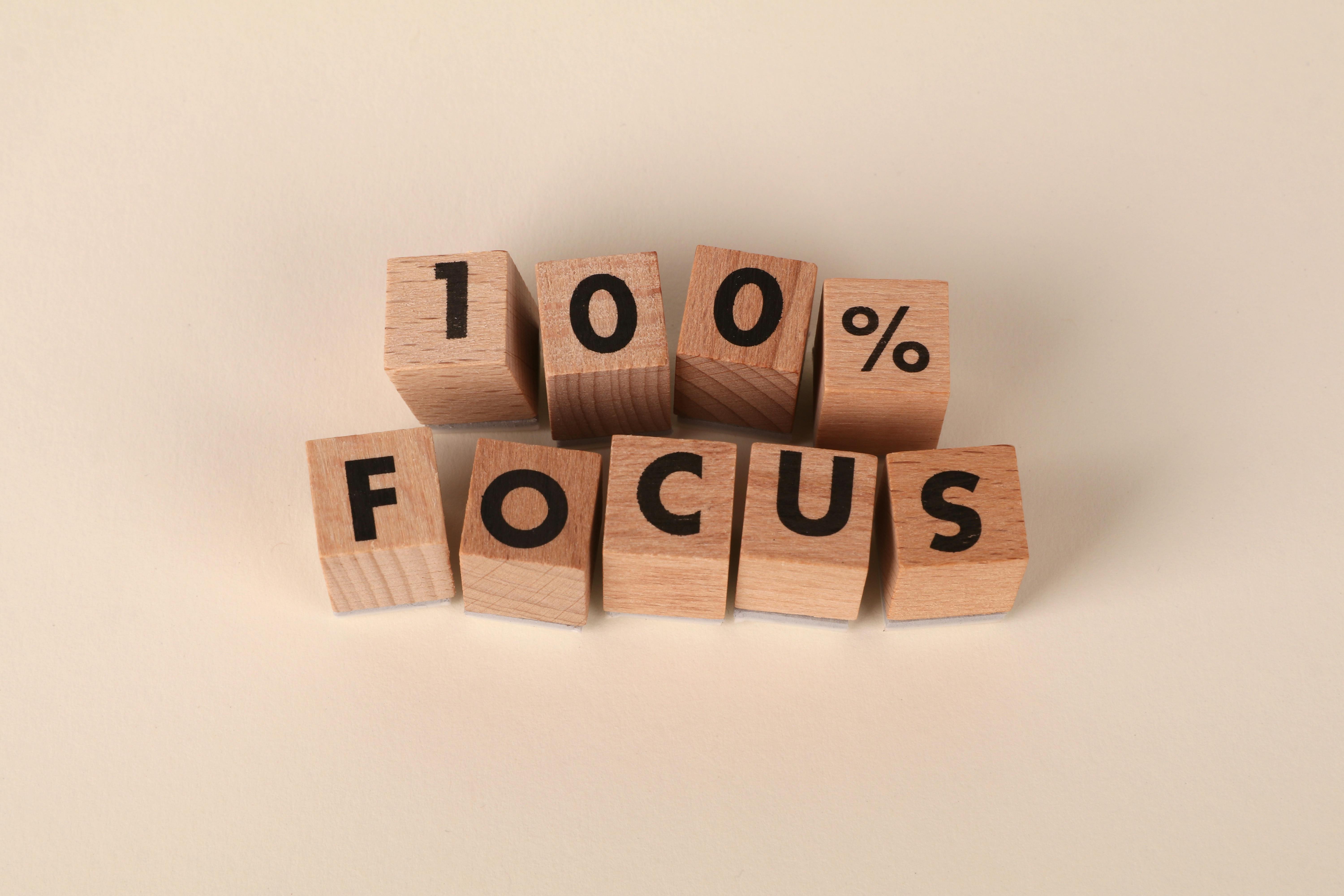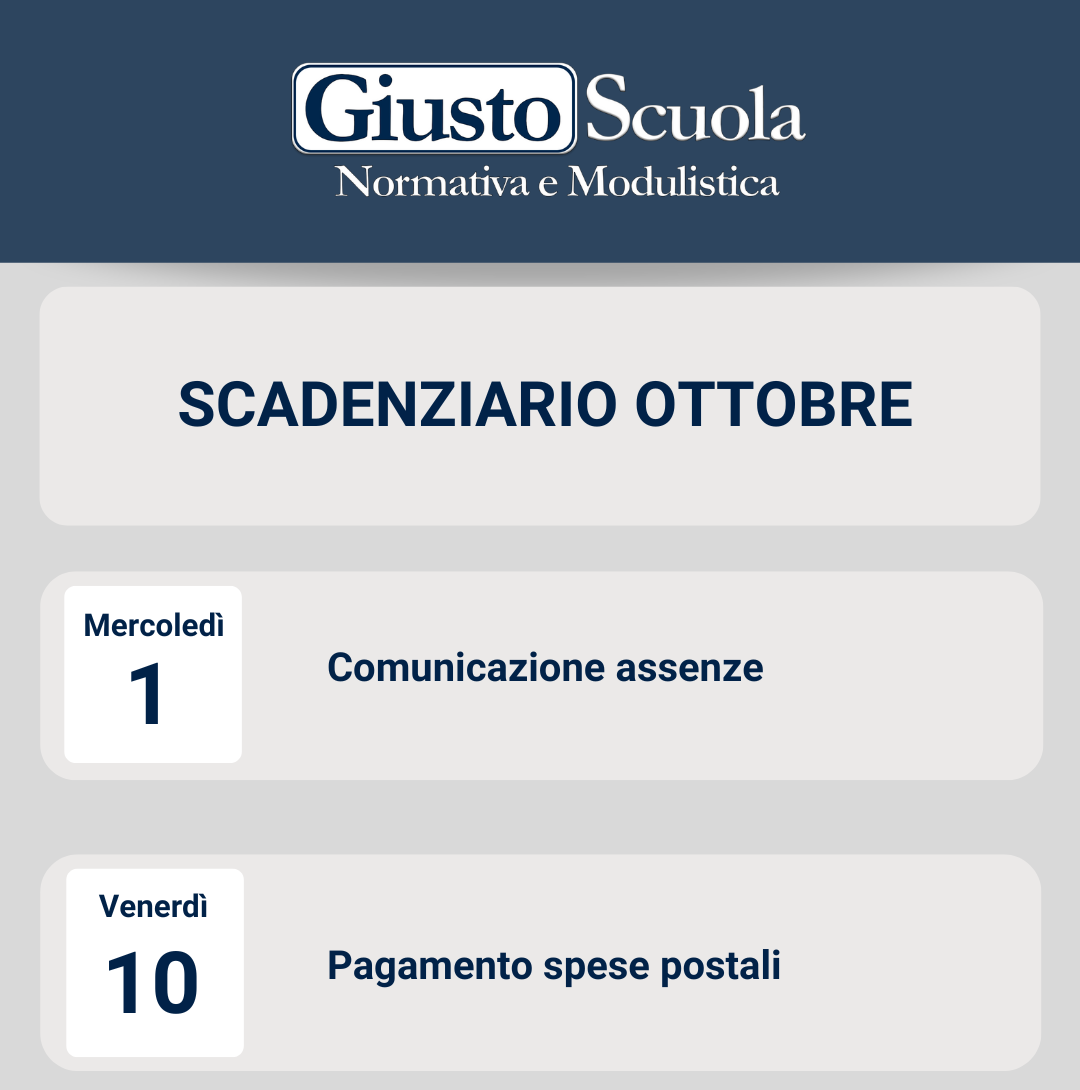La prima delle misure indicate nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale per l'anno 2021 prevede la progettazione di ambienti dedicati, oppure di dotare gli spazi interni delle aule con tecnologie specifiche per le STEM. Ad esempio, potranno essere acquisiti strumenti digitali per l’insegnamento dei principi fondamentali della programmazione, del coding, dell’intelligenza artificiale; per l’osservazione, lo studio e la ricerca nelle scienze; per la didattica laboratoriale della matematica; per la progettazione e creazione secondo le tecniche del making: Per la scuola dell’infanzia e primaria, sempre a titolo d’esempio - riferendosi all’approccio metodologico riassunto nelle 4P : Project (progetto), Peers (compagni), Passion (passione), Play (gioco) - potranno essere acquisite dotazioni di setting (materiali eterogenei e strumentazioni) per lo sviluppo di attività di computational tinkering , espressione che richiama l’armeggiare, il provare “questo e quello” alla ricerca della soluzione di un problema pratico, effettivo. Ancora, potranno essere acquisiti materiali e strumenti per realizzare l’approccio c.d. “trialogico” che, tramite tecniche tipiche dell’apprendimento collaborativo, realizza attività di costruzione di oggetti destinati ad un uso concreto . Ulteriori spunti di approfondimento sono rinvenibili nel Rapporto Finale del Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203 - Scuola ed Emergenza Covid-19 . Nella sostanza, l’utilizzo efficace delle risorse finanziarie comporta l’esercizio dell’autonomia di ricerca delle istituzioni scolastiche. Richiede altresì di definire preventivamente “il cosa e il come” sia bene sviluppare, in relazione al contesto di apprendimento e alla necessità di renderlo motivante. Senza motivazione gli studenti non sviluppano competenze ma archiviano informazioni e contenuti esclusivamente in vista del mero superamento delle prove scolastiche. Informazioni e contenuti peraltro spesso destinati ad essere dimenticati nel breve. Al contrario, l’approccio partecipato all’apprendimento scientifico e tecnologico è parte essenziale del Piano nazionale scuola digitale, così come dovrebbe esserlo per tutte le discipline.
Il digitale “amplificatore” di apprendimento
L’esperienza di questi due anni di emergenza sanitaria ha reso manifesta la necessità di percorsi di apprendimento nei quali le competenze digitali risultino sviluppate in modo integrato con i curricoli disciplinari. Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso alla Commissione Europea nei giorni scorsi , prevede specifici investimenti in abilità digitali e conoscenze applicative. Lo scopo è quello di creare nella scuola un diverso approccio al pensiero scientifico (es. IBL Inquiry Based Learning, Problem Solving, ecc.), sviluppando in tutti i gradi di istruzione le competenze STEM, digitali e di innovazione. La promozione della transizione digitale è anche priorità dell’Agenda europea e il “Piano d’azione per l’istruzione digitale” , adottato lo scorso ottobre, delinea la visione della Commissione per un'istruzione che favorisca l’acquisizione delle competenze digitali. Nel 2021 il PNSD si apre, dunque, a nuovi scenari derivanti dall’accelerazione, prodotta dalla pandemia, dei processi di innovazione di insegnamento e apprendimento. La sfida nel quotidiano di chi fa scuola è di volgere alla verifica critica del proprio agire, al cambiamento imposto dalla mutata realtà, intraprendendo o consolidando la personale transizione digitale, per una scuola centrata sulla persona in apprendimento, tesa ad accrescerne competenze adeguate e durature. La parola “competenza” assume quindi ancor più un significato cruciale, perché mutano rapidamente le competenze richieste dalla realtà in cambiamento. In questo tempo, compete alla scuola, cioè personalmente a ciascuno dei tanti che la realizzano quotidianamente, contribuire a rendere le nuove generazioni capaci di vivere in un mondo futuro assai diverso da quello praticato finora dagli adulti, ricco di sfide come pure di speranza.
Sitografia di riferimento
Mitchel Resnick, https://web.media.mit.edu/~mres/papers/constructionism-2014.pdf
Carmelo Presicce, “Explorations in computational thinkering” in Media Arts and Sciences - Master's degree, 2017, https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/114066.
Sul tema anche Mitchel Resnick - Natalie Rusk, “Coding at a Crossroads”, in Communications of the ACM, Novembre 2020, https://cacm.acm.org/magazines/2020/11/248219-coding-at-a-crossroads/fulltext. L’articolo è disponibile tradotto nel sito del Servizio Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2020/12/15/sul-coding-a-scuola-siamo-a-un-bivio/
Sami Paavola - Kai Hakkarainen, “La metafora della creazione della conoscenza: un approccio epistemologico emergente all’apprendimento”, Agosto 2005, Science and Education https://www.researchgate.net/publication/227313126_The_Knowledge_Creation_Metaphor_- _An_Emergent_Epistemological_Approach
L’approccio “trialogico” integra la componente individuale (approccio “monologico”) e sociale (approccio “dialogico”) dell’apprendimento, attraverso un terzo elemento: i processi intenzionali nel produrre collaborativamente artefatti di conoscenza condivisi, utili e motivanti. Sansone, Cesareni, Ligorio, “Il Trialogical Learning Approach per rinnovare la didattica”, https://ijet.itd.cnr.it/article/download/892/758
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it