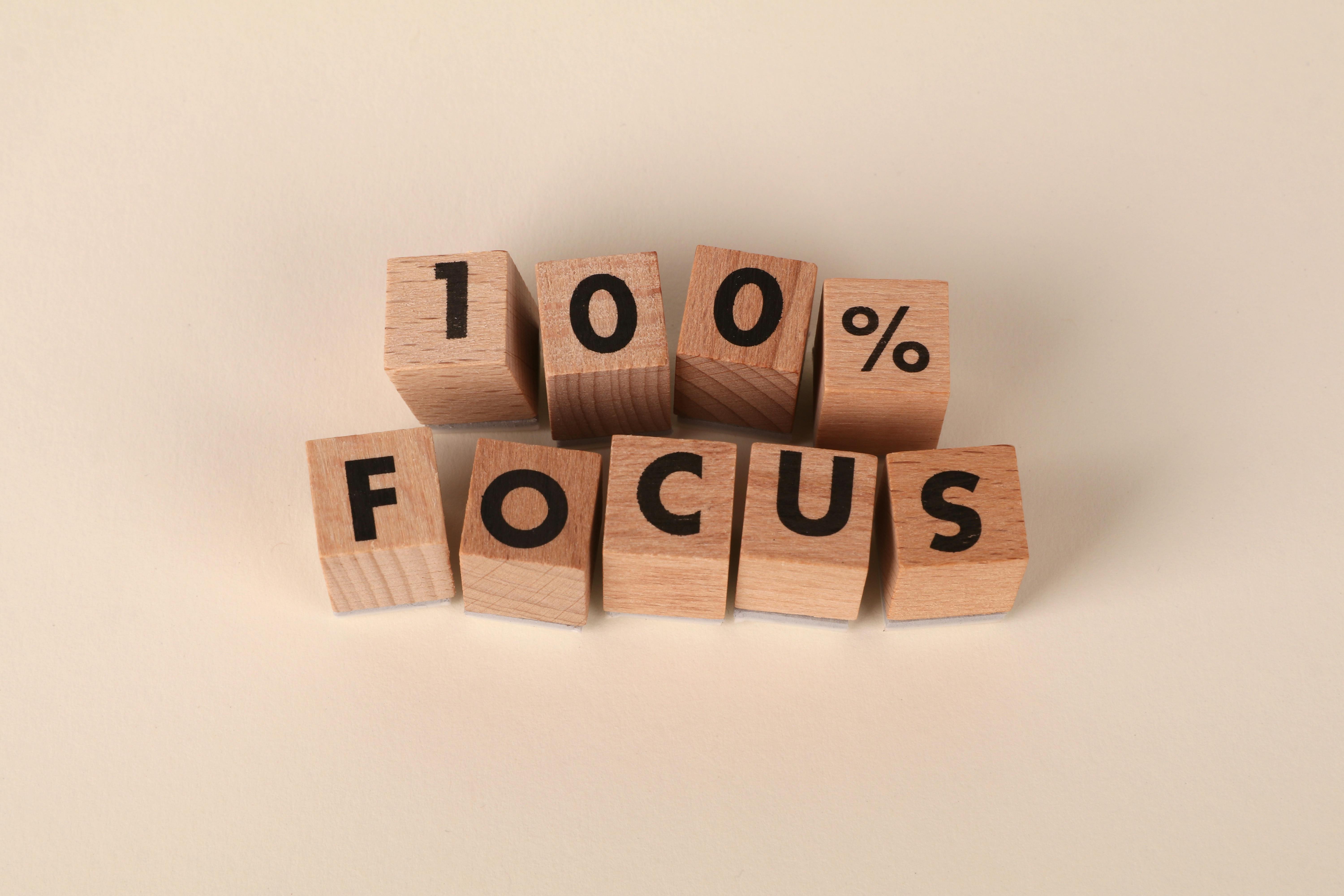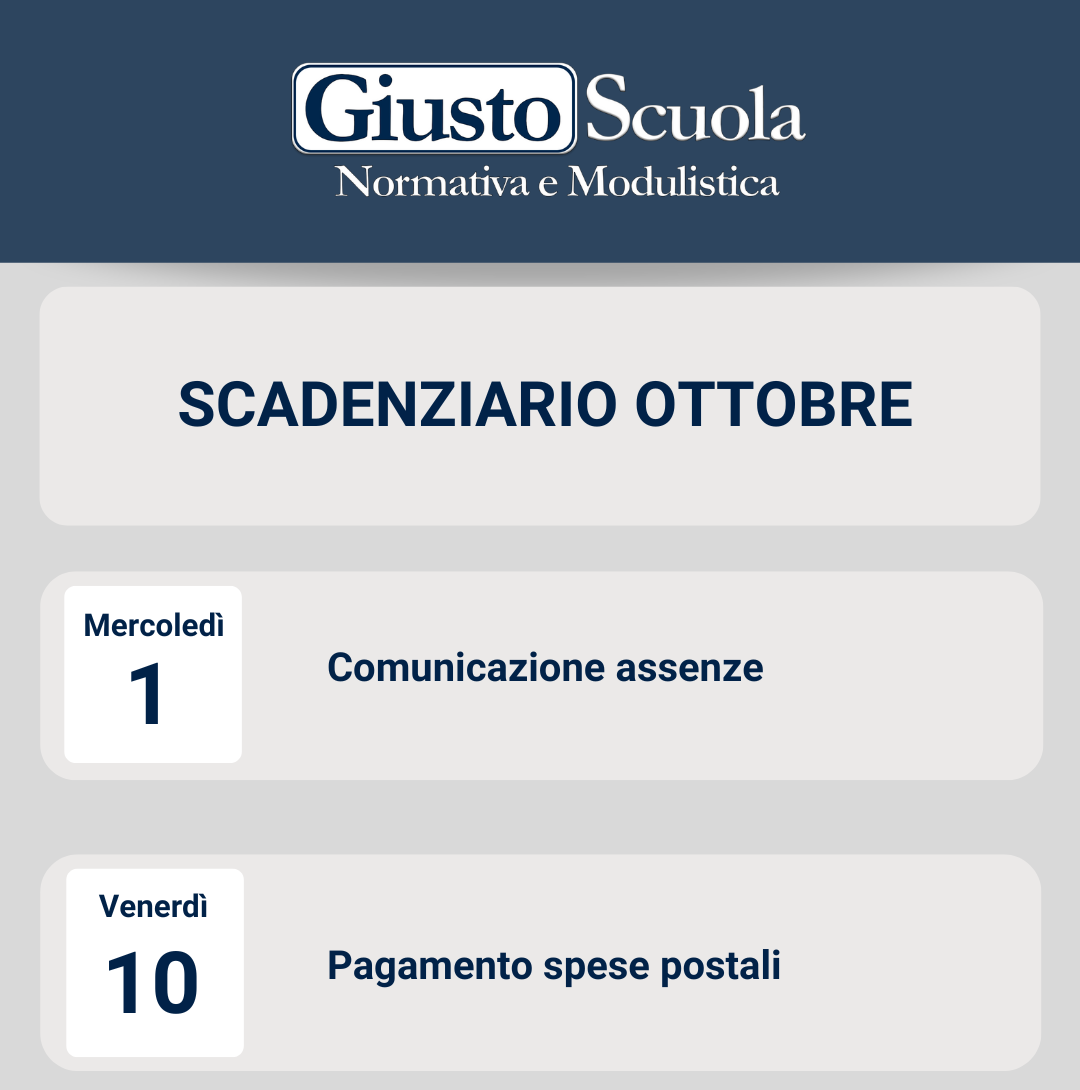Nel caso di specie un lavoratore agiva in giudizio per il risarcimento del danno alla salute asseritamente subito in relazione a atti e comportamenti adottati dal datore di lavoro nei suoi confronti.
Il Giudice di appello nel rigettare il ricorso del lavoratore e in riforma della sentenza del giudice di primo grado aveva affermato che nel caso in esame non era dato riscontare nei predetti atti e comportamenti datoriali quel comune intento persecutorio rappresentante un elemento costitutivo del c.d. mobbing, nonché delle ipotesi di c.d. straining. Riteneva inoltre che, sebbene fosse pacifico tra le parti che le accertate patologie del dipendente discendessero dallo stress lavoro-correlato, tale risultanza, disgiunta da un comportamento programmaticamente vessatorio da parte del datore di lavoro, non fosse sufficiente a far sorgere in capo al medesimo una responsabilità risarcitoria ex art. 2087 cod. civ.
Il lavoratore contro la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno differenziale per violazione dell'art. 2087 cod. civ. a prescindere dalla sussistenza di un intento vessatorio datoriale.
A fronte di tali censure, la Corte di Cassazione nel decidere l'accoglimento del ricorso con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 2084
ha affermato che al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un "unificante comportamento vessatorio", ma è sufficiente l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici.
A fondamento della propria decisione la Corte ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità del datore ex art. 2087 cod. civ., con tutte le conseguenze del caso, anche in tema di prescrizione e onere della prova. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, la Cassazione ha ricordato che «il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni causati dall'espletamento dell'attività lavorativa non ha l'onere di dimostrare le specifiche omissioni datoriali», essendo, al contrario, «onere del datore di lavoro provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno» ritenendo, inoltre, che la «portata costituzionale della materia trattata» ha spinto ad ammettere che le condotte potenzialmente lesive dei diritti di cui si tratta siano «soggette a prove presuntive», di talché - a fronte di una pluralità di fatti emersi nel corso dell'istruttoria - sarebbe richiesto al Giudice di valutarli «tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri», restando esclusa la possibilità di valutarli, invece, «singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova». Chiarito ciò, la Cassazione ha, poi, richiamato un proprio precedente in materia, secondo cui, in relazione alla tutela della personalità morale e della salute del lavoratore - al di là della qualificazione come cc.dd. mobbing e straining - quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, tra cui la sua integrità psico-fisica. Secondo la Suprema Corte, infatti, «la reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza»