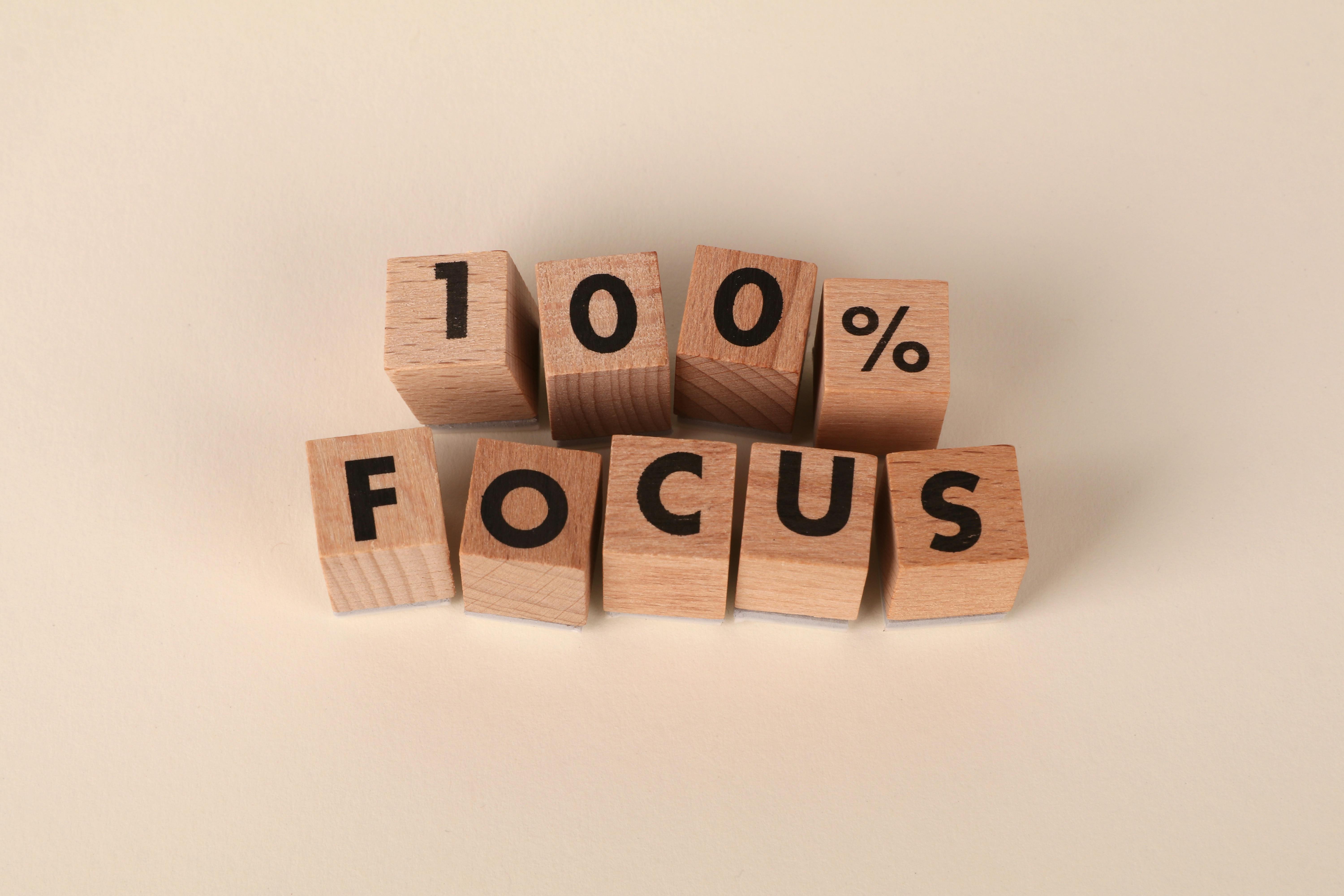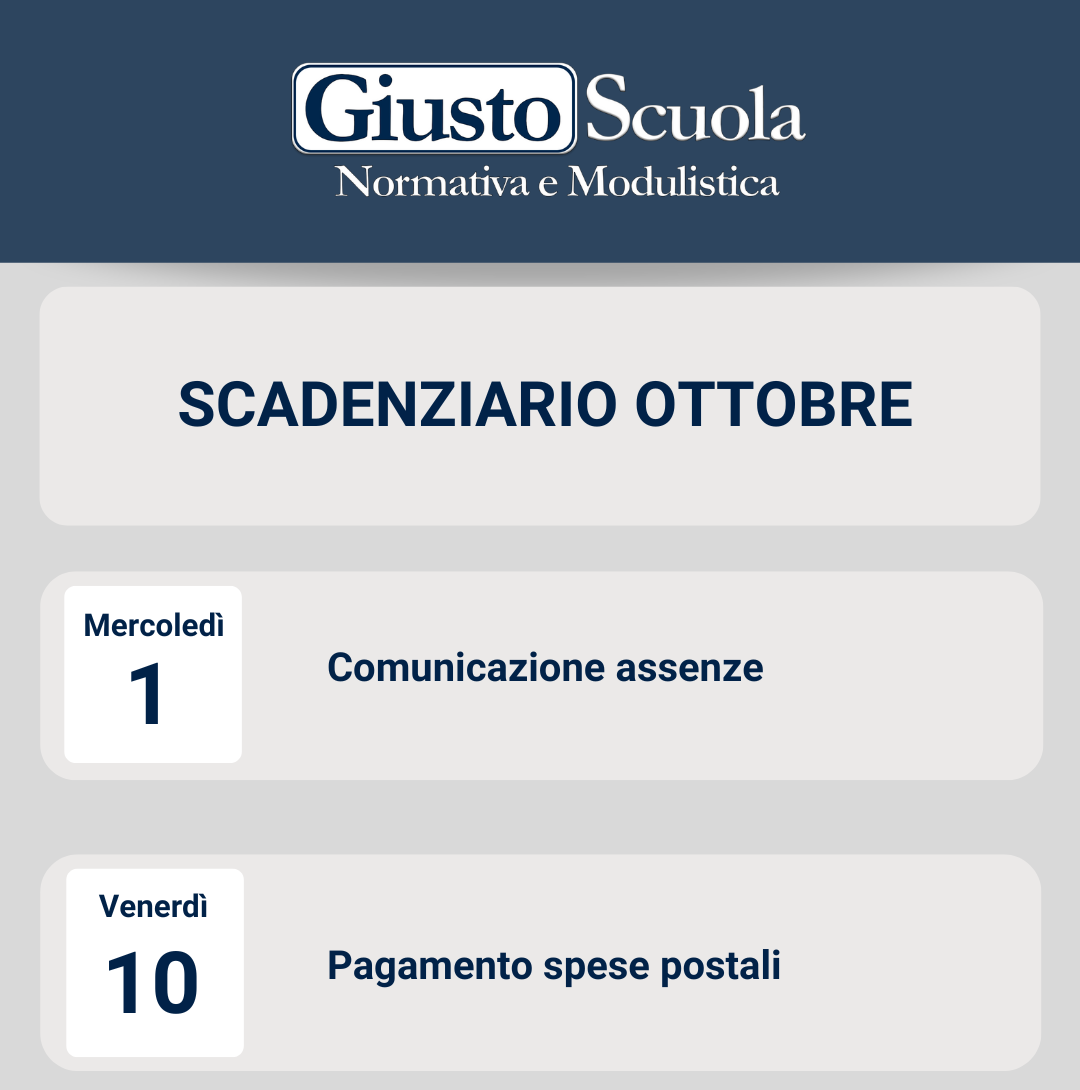Pubblicato per Scienza dell'amministrazione scolastica n. 2 - 2025
di Lorenzo Pianfetti
Dottore in Giurisprudenza
“A chi dunque dobbiamo affidarli? Chi è abile a sviluppare in loro le virtù proprie dell’uomo del cittadino?”(1)
Giugno è un mese poliedrico. Rappresenta il fiorire dell’e state, è foriero di un inebriante vento di vivace allegria e leggera sconsideratezza tra “la meglio gioventù”, impaziente di mettervi all’ultimo libro dal banco di scuola e dare inizio all’imminente vacanza che l’aspetta da qui fino ai prossimi tre mesi successivi. A questa visione dai ca ratteri idilliaci, tuttavia, s’accompagna una realtà ben più pragmatica e inesorabile, quasi come se chiamata a dover sopire questo ardore di spensieratezza: giugno sta, infatti, a significare anche conclusione dell’anno scolastico, con siglio di classe, scrutinio finale, valutazioni, prove finali e, ahimè, possibili ed (in)evitabili bocciature. Senza alcuna pretesa di esaustività, il presente contributo si pone l’obiettivo di fornire un quadro prospettico circa le modalità e i limiti che incontra il sindacato di legittimità del giudice amministrativo in merito alle valutazioni scolastiche. L’organo giurisdizionale è chiamato ad espri mersi in occasione di taluni ‘momenti patologici’ rispetto al fisiologico sviluppo formativo ed educativo dello stu dente: in altre parole, si allude cioè alle ipotesi di non am missione alla classe successiva ovvero all’esame di Stato nonché al mancato superamento di quest’ultimo per ritenuta inidoneità. La riflessione che ruota attorno al giudizio valutativo, e le relative considerazioni che ne derivano, assumono ancor più pregnanza nel momento in cui si pone attenzione al significato che l’attività di valutazione viene ad assumere rispetto al contesto entro cui questa si esplica.
La prospettiva europea
Gli anni Novanta del secolo scorso hanno rappresentato per l’UE un periodo di profondi cambiamenti. In partico lare, avvertita la necessità di concepire un nuovo assetto strategico volto al rafforzamento della competitività dei propri mercati, il fattore di rilancio dell’economia euro pea viene individuato nell’alta formazione e nella ricerca scientifica, ambiti fino a quel momento ritenuti di margi nale interesse nel processo di integrazione europea. Si è quindi dato luogo alla creazione di uno spazio europeo dell’istruzione. “Il cuore della scuola”(2), e cioè il contenuto dell’insegna mento e l’organizzazione del sistema di istruzione, è lasciato nella completa disponibilità degli Stati membri(3). Ciò di cui si vuole occupare l’Unione è lo “sviluppo di un’istruzione di qualità”, obiettivo per il quale l’Unione stessa si propone di svolgere un ruolo di agevolazione, impegnandosi a favorire la cooperazione tra gli Stati e a mettere in campo ogni opportuna azione di sostegno, eventualmente integrando ciò che essi si propongono, in modo del tutto spontaneo e indipendente, di effettuare in questa direzione(4). L’UE si limita all’adozione di idonee azioni di incentivazio ne e alla formulazione di raccomandazioni. Eppure, affer mare che l’Unione si può occupare dell’output dell’istru zione in termini di qualità equivale a stabilire: a) che quell’output è misurabile e valutabile secondo cri teri che sono esterni agli Stati membri, e che avranno ine vitabilmente a che fare con gli obiettivi di sistema dell’U nione; b) che tale verifica sarà rilevante sia ai fini dello specifico supporto sovranazionale, laddove di volta in volta previ sto, sia nella prospettiva di agevolare o rendere ancor più effettivo il raggiungimento degli obiettivi generali unio nali. L’obiettivo dell’UE è infatti la piena occupabilità dell’indi viduo. In una simile prospettiva, le valutazioni (a qualun que livello e di qualunque tipo) vengono dunque a por si quali frammenti di percorso per la costruzione di uno scopo ben definito: oggigiorno, gli standard di qualità europei individuano il fine specifico tale per cui il soggetto dev’essere indirizzato verso una traiettoria formativa che gli consenta la massima occupazione (meccanismo di funzionalizzazione del sistema di istruzione). Si ritiene che l’Europa della conoscenza rappresenti un insostituibi le fattore di crescita sociale ed umana nonché un elemen to indispensabile per consolidare ed arricchire la cittadi nanza europea (passaggio dalla formazione di capitale umano alla creazione di capitale intellettuale).
Il rapporto insegnante-alunno
Il legame tra un allievo e il suo insegnante ha origini an tiche (tra tutti, vengono alla mente i noti rapporti che fi losofi del calibro di Socrate, Platone ed Aristotele erano soliti instaurare con i propri discenti) e da sempre rappre senta un pilastro importante nel processo educativo e formativo del singolo. Nonostante la sua evoluzione abbia risentito dei modelli educativi adottati nel corso tempo, passando da una di mensione prevalentemente autoritaria e disciplinare a una prospettiva più collaborativa e incentrata sull’empo werment degli allievi, agli occhi del diritto, tale rapporto rappresenta una relazione giuridicamente significativa nell’ambito dell’istruzione. Si tratta di una relazione di matrice formativa, prolungata nel tempo, in cui un soggetto (allievo o discente) è chia mato a svolgere attività di studio, approfondimento, ricer ca e/o apprendimento sotto la guida, la supervisione e il giudizio di un diverso individuo (docente). Quest’ultimo non risulta formalmente e direttamente responsabile dei risultati accademici raggiunti dall’allievo, ma assume co munque obblighi di didattica e di insegnamento nei suoi confronti. Il rapporto insegnante - allievo trova un espresso ricono scimento costituzionale. All’indomani del venir meno dello Stato ideologico, al fine di soddisfare la necessità di garantire la laicità (non solo in senso religioso ma anche politico e culturale) del sistema scolastico italiano, il Costituente ha deciso di voler presi diare a tale esigenza attraverso la norma di cui all’art.33 Cost. Il perimetro coperto dalla norma costituzionale si identifica con l’attività di insegnamento che, come tale, differisce dalla garanzia apprestata in favore di ogni e qualunque manifestazione del pensiero: in particolare, secondo un rapporto di genus a specie, la libertà di inse gnamento rappresenta il precipitato della più generale libertà di manifestazione del pensiero. Il co.1 dell’art.33 Cost. afferma “l’arte e la scienza sono li bere e libero ne è l’insegnamento”: in tal senso, la libertà di insegnamento deve essere intesa secondo una duplice accezione, e cioè, non soltanto come libertà del docente di determinare il contenuto del proprio insegnamento (li bertà negativa contro possibili interferenze praticate sul docente da parte dello Stato) ma anche come libertà di chiunque possieda i requisiti di idoneità e disponibilità a svolgerlo di accedere alle strutture in cui deve essere impartito(5). Il diritto alla libertà di insegnamento consiste essenzial mente nella scelta delle modalità e dei contenuti dell’inse gnamento stesso, nel rispetto dei programmi nonché dei fondamentali criteri di esercizio della funzione docente. La libertà di insegnamento rappresenta il portato di una cultura liberale orientata a garantire l’indipendenza del docente rispetto a possibili pretese avanzate dallo Stato: nell’ambito della scuola pubblica il principio della laicità impone neutralità e pluralismo. Come stabilito dal T.U. n.297/1994 sullo stato giuridico de gli insegnanti, l’incidenza di atti autoritativi concretamen te idonei a modificare l’attività di insegnamento, indiriz zandola verso schemi o linee non logicamente scaturenti dall’insegnamento stesso, viene a ledere l’autonomia e la dignità in esso radicate. Pertanto, l’amministrazione può organizzarsi secondo moduli che ritiene più opportuni, stabilendo metodi di insegnamento diversi da quello compiutamente previsto da disposizioni vigenti come il tempo pieno, ma nel far ciò è tenuta a rispettare i limiti derivanti dal citato principio della libertà di insegnamen to, in base al quale le è negato di introdursi nel rapporto didattico, imponendo le caratteristiche e le modalità per impartire l’insegnamento(6). In generale, il sistema scolastico è tuttavia modellato anche in base all’esigenza di proteggere la libertà del di scente e, valorizzando le connessioni con l’art.30 Cost., della sua famiglia nella scelta di un determinato orienta mento culturale ai fini della propria formazione. In proposito, si evidenzia come occorra distinguere tra scuola pubblica e scuola privata. La prima deve garantire al suo interno il più ampio plura lismo metodologico, al fine di consentire effettivamente il libero accesso e le libere scelte da parte degli utenti; il solo limite che può derivare al docente è quello dettato dal rispetto dei programmi eventualmente disposti dal gestore della scuola. Diversamente, nella scuola privata il rapporto docente scuola incontra l’ulteriore limite derivante dal particolare indirizzo ideologico della scuola: in tale contesto, occorre che la filosofia dell’insegnamento, nelle sue svariate arti colazioni, risulti coerente con l’ispirazione laica o religiosa dell’istituto scolastico al fine di non frustrare l’affidamen to per la libertà di scelta degli utenti.
Il sindacato di legittimità del giudice ammi nistrativo sulle valutazioni scolastiche
La scuola è un ambiente peculiare per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, gli organi chiamati ad esprimere il giudi zio di valutazione (insegnanti e consiglio di classe) hanno caratteri propri ed esclusivi rispetto a quelli ordinaria mente previsti nella pubblica amministrazione. Secondariamente, la scuola si pone quale terreno di con 20 vergenza tra contrapposte dinamiche intercorrenti tra più soggetti: l’attribuzione di valutazioni scolastiche rappre senta la sintesi del fisiologico conflitto tra l’insegnante (e il relativo collegio) e il singolo studente, su cui s’innesta l’in teresse (non secondario) della famiglia. Quest’ultima non riveste il semplice ruolo di interlocutore tra le due parti contrapposte, ma è proprio la volontà della famiglia che fonda la decisione di contestare la valutazione negativa dinanzi all’organo giurisdizionale. In tale ambito, il giudice è chiamato a pronunciarsi sull’e sercizio di un potere tecnico discrezionale: le valutazioni scolastiche sono qualificabili infatti alla stregua di valu tazioni tecniche da parte della Amministrazione. Si tratta di un momento specifico in cui colui che fa istruzione (insegna) esercita tecnicamente un potere: nel misurare il grado e il valore di conoscenza acquisita da parte di un soggetto, si ha l’applicazione di un sapere che è tecnico, poiché appartiene a una (o più) specifica disciplina ed è dunque proprio della relativa comunità scientifica di rife rimento. Peraltro, è necessario evidenziare come l’esercizio di sif fatto potere rappresenti uno soltanto dei momenti che caratterizzano la vita scolastica: la dottrina in merito impiega la locuzione “rapporto scolastico”, con ciò desi gnando la relazione che dà vita e caratterizza il rapporto insegnante-alunno e che si esprime in termini di attività complessa che, in linea di principio, è sottratta a qualun que regola, anche di carattere amministrativo, perché avente natura e fondamento epistemico. Il momento di valutazione costituisce il fine ultimo di tale attività, la quale, comunque, conserva uno spazio riserva to (nucleo duro) rispetto al quale nessuno può intromet tersi. In tale prospettiva, assume un ruolo saliente la pedago gia: si ritiene che tale scienza rappresenti infatti il medium di trasmissione del sapere che consente al docente di vei colare la propria disciplina nei confronti del destinatario dell’insegnamento. Alla luce di tali considerazioni, se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione (insindacabilità del giudizio tecnico in at tuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri), è anche vero che non può esimersi dal considera re e valutare se l’Amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevo lezza tecnica: al fine di fornire certezza e garantire i desti natari dall’esercizio di tal potere, le valutazioni tecniche sono dunque soggette al sindacato giurisdizionale entro i canoni della ragionevolezza, dell’assenza di evidenti e pa lesi contraddittorietà logiche o abnormità di fatto. Dunque, concretamente, come si traduce tutto ciò nel si stema scuola? In tale contesto, si assiste alla tendenza da parte dell’ordi namento a formalizzare il rapporto scolastico. Maggiore è la formalizzazione dell’attività, maggiore sarà lo spazioper il sindacato: oltre al rispetto di determinati principi generali dell’ordinamento, in particolare quelli in materia di difesa tecnica (segnatamente quelli in tema di contrad dittorio) nonché quelli in materia di partecipazione, il do cente, e più in generale il consiglio di classe, è chiamato a formulare un preciso itinerario argomentativo prece dente alla valutazione. Ed è proprio tale formalizzazione che rivela (e implica) come il vaglio del giudice non deb ba concentrarsi esclusivamente sulla singola valutazione, dovendo invece tener presente l’intero percorso formativo, nel quale assumono rilevanza non solo il contesto ma anche (e soprattutto) la singola e specifica situazione scolastica dell’alunno oggetto di giudizio.
Scuola secondaria di primo grado
Preliminarmente, si espone una sintetica ricostruzione della normativa che disciplina il processo formativo e i ri sultati di apprendimento degli alunni che frequentano il primo ciclo di istruzione scolastica. L’articolo 1 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 627 enuncia i se guenti principi generali: a) la valutazione dell’alunno deve favorire il miglioramen to degli apprendimenti e il successo formativo (comma 1); b) il percorso formativo dell’alunno deve essere persona lizzato (comma 2); c) le istituzioni scolastiche devono favorire i rapporti scuola-famiglia con l’adozione di modalità di comunica zione efficaci e trasparenti (comma 3). Il successivo art. 6 del medesimo decreto disciplina l’am missione dell’alunno alla classe successiva, la quale può essere negata dal Consiglio di classe in casi eccezionali (comma 1), previo assolvimento dell’onere di fornirne una motivazione adeguata (comma 2) e dell’onere di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di ap prendimento parzialmente raggiunti (comma 3). In particolare, per casi eccezionali, s’intendono le ipotesi di gravi sanzioni disciplinari ovvero di parziale o totale ac quisizione di livelli di apprendimento di disciplina. Stando alla lettera della norme, dunque, in tali circostanze, in via di eccezione ai principi generali del favor per il migliora mento degli apprendimenti e per il successo formativo, il Consiglio di classe può deliberare con adeguata motiva zione la non ammissione alla classe successiva. In merito, però, in considerazione delle peculiari difficol tà insite nel passaggio dal ciclo di studi della scuola pri maria a quello della scuola secondaria di primo grado, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con circolare n. 1865 del 10 ottobre 2017, ha affermato che “l’ammissione alle classi seconda e terza della scuola se condaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di ap prendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio f inale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione (...)”. Analogamente, la giurisprudenza ritiene che l’ammissio ne degli studenti della scuola secondaria di primo grado alla classe successiva rappresenti la regola generale e che le eventuali carenze nell’acquisizione dei livelli di appren dimento in una o più discipline non siano idonee a giustifi care la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, la quale può essere deliberata solo all’esito di una verifica negativa della possibilità di recupero, nel corso dell’anno scolastico successivo, delle carenze riscontrate(8). Il Consiglio di Classe è dunque tenuto ad effettuare una valutazione complessiva dei livelli di apprendimento rag giunti dall’alunno, che si estenda, ove l’alunno non abbia acquisito, in tutto o in parte, i livelli di apprendimento in una o più discipline, ad un periodo di tempo eccedente il primo anno scolastico, sufficiente a garantire l’adatta mento del minore al nuovo ciclo di istruzione(9). Ne consegue che, la non ammissione dell’alunno alla clas se successiva alla prima media deve essere circoscritta a quei casi eccezionali in cui, nonostante l’attivazione e l’e spletamento di “specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”, l’alunno non venga ritenuto in grado di colmare le riscontrate lacune nel corso dell’anno scolastico successivo. Alla luce di tale orientamento, che rispecchia un’imposta zione di matrice pedagogista, rispetto a coloro che fre quentano la scuola secondaria di primo grado (ma tale ra gionamento è stato esteso anche rispetto agli alunni della scuola primaria), la presenza di insufficienze, corroborata da una motivazione rafforzata, non è elemento, di per sé, idoneo a giustificare la non ammissione alla classe suc cessiva(10). Emergono peraltro evidenti difficoltà pratiche per gli insegnanti che riscontrino tali (precarie) situazioni di preparazione dell’alunno. Tuttavia, sebbene in conseguenza dell’affermazione di una tale impostazione il numero di ricorsi che lamenta vano l’illegittimità della non ammissione sia accresciuto esponenzialmente, parte della giurisprudenza ha ricali brato la portata di una siffatta interpretazione: la non am missione dell’alunno alla classe successiva ben può essere legittima se fondata su di una motivazione rafforzata in cui Consiglio di classe valuta e si esprime su quale possa essere il percorso scolastico più adeguato. In particolare, soffermandosi attentamente sull’analisi della situazione scolastica personale dell’alunno, al fine di fornire una mo tivazione congrua e rafforzata circa la ritenuta bocciatura e le capacità del soggetto, il consiglio di classe è chiamato ad esprimere un giudizio analitico basato su dato ogget tivo(11). A fronte di tale orientamento, ripetere l’anno, dunque, è una possibilità che permette il reale potenziamento delle competenze e innalza il livello di apprendimento in modo da garantire il successo formativo nel prosieguo della for mazione scolastica del singolo.
Soggetti con disturbi specifici di apprendi mento (DSA)
L’articolo 11, commi 9 e 10, d.lgs. 62/2017 disciplina, ai f ini della ammissione alla classe successiva, la valutazio ne dell’alunno con disturbi specifici di apprendimen to certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tale giudizio deve essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP), predisposto dai docenti in ragione delle condizioni di disturbo dell’apprendimento del sin golo, nel quale sono individuate le misure dispensative e gli strumenti compensativi idonei a consentire all’alunno di dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito. Secondo la giurisprudenza, in simili situazioni è necessa rio che l’organo collegiale esperisca un esame valutativo concernente il rapporto tra la valutazione scolastica irro gata (che esprime la capacità di accesso alla classe succes siva) e le personali capacità del soggetto, richiedendosi, in ogni caso, un determinato livello di maturazione, seb bene alla stregua di parametri differenti rispetto a quelli ordinariamente richiesti (idoneità della motivazione del giudizio di non ammissione prendendo adeguatamente in considerazione la condizione di DSA dell’allievo)(12). Ulteriormente, si rende necessaria l’analisi circa il rappor to tra le insufficienze riscontrate e il piano educativo indi vidualizzato: in merito si osserva come, laddove il PDP sia stato predisposto tardivamente ovvero risulti inadeguato, allora è inevitabile che il soggetto non sia in grado di rag giungere un sufficiente livello di maturazione per l’acces so all’anno successivo. Quanto alla prospettata mancata applicazione delle misu re compensative previste nel PDP, l’orientamento preva lente dispone che, “vertendosi in materia di causalità omis siva, va posto in capo alla parte ricorrente un onere di fornire la prova - anche in via presuntiva e probabilistica - del fatto che un più ampio utilizzo degli strumenti compensativi/di spensativi previsti dal PDP avrebbe, con alto livello di proba bilità, migliorato i risultati scolastici del soggetto a tal punto da ribaltare i risultati deficitari ottenuti nel corso dell’anno e condurre a diverso esito lo scrutinio di fine anno”(13). Inol tre, giurisprudenza costante e ormai consolidata afferma come in tali ipotesi, così come nel caso in cui l’attivazione dei corsi di recupero a fine anno risulti soltanto parziale,i genitori, eventualmente, possono esperire azione di re sponsabilità avverso la scuola(14).
Scuola secondaria di secondo grado
In merito al giudizio di valutazione, per la scuola supe riore, si osserva come sia sufficiente la presenza di un’in sufficienza al fine di comportare la non ammissione alla classe successiva ovvero all’esame di maturità(15). Peraltro, è bene evidenziare che, certamente, tale giudizio nega tivo esprime la manchevole preparazione dello studente a progredire nel percorso scolastico, ma, sotto diverso punto di vista, può essere anche letto quale occasione di “fallimento professionale” da parte di cui che l’ha formato. In relazione alle fattispecie proprie di tale ambito (non ammissione a classe superiore, nonché all’ esame di ma turità) la materia scolastica si è rivelata innovativa: si è infatti avuta una significativa tendenza ad applicare la tecnica del remand. In ragione dell’attribuzione all’organo giurisdizionale dell’ampio potere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare in via provvisoria (fase cautelare) gli effetti della decisione sul ricorso proposto, il giudice sospende il provvedimento impugnato e contestualmente ordina alla Amministrazione resistente in giudizio di riesaminare la situazione sulla base di parametri e criteri indicati dallo stesso giudice. Tale tecnica processuale ha quindi l’effetto 22 di permettere di rimettere in gioco l’assetto degli interessi già in precedenza definito dall’Amministrazione e ora og getto di nuova rivalutazione. Nel sistema scuola, alla luce di quanto sopra evidenziato, la (ri)valutazione è di necessaria competenza dell’istituto scolastico, non potendo il giudice sostituirsi nel giudizio rispetto a tale rapporto. In ogni caso, laddove il Consiglio di classe si pronunci nuovamente, ciò costituisce un nuo vo giudizio avente valore costituito, ossia di un provve dimento di conferma in senso proprio, e non già un atto meramente confermativo(16). All’atto pratico ne deriva che: a) il Consiglio di classe valuta nuovamente la situazione scolastica complessiva dello studente alla luce delle lacu ne censurate dal giudice; b) il Consiglio di classe si esprime sull’eventuale ripetizio ne dell’esame finale da parte del soggetto (di frequente, nuovo svolgimento dell’orale di maturità con differenti membri componenti la commissione valutatrice); c) nelle more del nuovo giudizio, e della relativa pronun cia definitiva, dell’organo collegiale scolastico, il giudice ammette (con riserva) direttamente lo studente alla clas se successiva ovvero all’esame finale. In ordine all’ipotesi sub c), solitamente è la più frequente, si ritiene opportuna l’analisi di un recente caso pratico cui è stata chiamata la giurisprudenza, il quale presente sì un contenuto fattuale peculiare ma che, rispetto alla realtà quotidiana, può apparire come non così insolito(17). Il Consiglio di classe è propenso a non ammettere alla classe successiva un alunno che presenta in tre distinte materie un livello di preparazione insufficiente, e nono stante alla fine del trimestre presentasse, per ciascuna, una votazione superiore alla sufficienza. Il giudizio viene così sospeso in vista degli esami di recupero in settembre. All’esito di questi, lo studente recupera, raggiungendone la sufficienza, soltanto in una materia sicché il Consiglio si pronuncia per la non ammissione. La decisione viene impugnata e viene richiesta, in sede cautelare, stante la parvenza di una situazione connotata da estrema gravità e urgenza (imminente inizio dell’an no scolastico che, nel caso di specie, corrisponde all’anno della maturità), l’ammissione con riserva alla classe suc cessiva. Il giudice di primo grado accoglie l’istanza e fis sa la decisione in novembre, e cioè ad (successivo) anno scolastico iniziato e in corso di frequentazione da parte dell’alunno. All’esito delle risultanze probatorie, e in particolare delle valutazioni esperite dal Consiglio di classe(18), il giudice si pronuncia negativamente rispetto alla situazione scola stica in esame, respingendo il ricorso. Viene dunque pro posto appello e proposta nuovamente istanza cautelare al fine di ottenere una celere (seppur parziale) pronuncia stante la particolarità della situazione fattuale Il giudice d’appello accoglie l’istanza e, successivamente, conferma quanto pronunciato in sede cautelare in primo grado: lo studente è legittimamente ammesso alla classe successiva e può portare a termine il proprio ciclo di studi. La decisione è significativa poiché il giudice d’appello compie una valutazione complessiva del percorso forma tivo dell’alunno, non focalizzandosi esclusivamente sulla sussistenza di insufficienze riportare a fine anno, bensì valorizzando quanto raggiunto in termini di preparazione non solo durante i precedenti trimestri, ma anche l’anda mento scolastico dello studente nei precedenti anni di scuola superiore, rilevando come costui, sebbene avesse avuto qualche carenza in talune materie, avesse sempre raggiunto la soglia della sufficienza. All’esito di tale giudizio complessivo (comparativo) relati vo all’intero rapporto scolastico tra l’istituto e lo studente, viene dunque censurata la decisione finale del Consiglio di classe, evidenziando come i motivi da questo esposti, e che giustificavano la non ammissione (presenza di gra vi lacune pregresse sin dall’inizio dell’anno scolastico), non fossero fondati, con ciò comportando, dunque, l’inevita bile illegittimità della decisione assunta.
(1) Apologia di Socrate, La difesa di Socrate, cap. IV, Socrate non conosce, come i sofisti, l’arte di educare gli uomini.
(2) Espressione di F. Cortese, L’istruzione tra diritto europeo e diritto nazionale, in Munus, fasc.3, 2015, p.508.
(3) Art. 2 co. 5 e 6 TFUE.
(4) Art. 165 TFUE.
(5) Sul punto,Corte Cost. n. 141/1979.
(6) Sul punto, TAR Sicilia, Palermo, n. 12/1986.
(7) Rubricato“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato,a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
(8) Ex multis, Consiglio di Stato, sezione VII, 29 settembre 2022, n. 8384.
(9) Consiglio di Stato, sezione VI, 24 ottobre 2018, n. 5169. Di recente, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 agosto 2024, il quale, ri tenendo come l a non ammissione ha carattere eccezionale e può essere disposta quale extrema ratio, accoglie la richiesta cautelare formulata da parte ricorrente non già in termini di ammissione dell’alunno alla classe successiva, ma soltanto ai fini di un riesame della posizione dello studente da parte del Consiglio di classe nel corso del secondo anno del ciclo scolastico.
(10) Cons. Stato, sez.VI, 20 gennaio 2021, n. 638, secondo cui “l’ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo grado alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo costituisce la regola generale, derogabile soltanto ove risultino condotte rilevanti sul piano disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 6, DPR 24 giugno 1998, n. 249 ovvero si riscontri una parziale o mancata acquisizione da parte dell’alunno dei livelli di appren dimento in una o più discipline. In tale ultima ipotesi, affinché il consiglio di classe, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, possa legittimamente rifiutare l’ammissione dell’alunno alla classe successiva, occorre una decisione espressa corredata da”adeguata motivazione”, dovendo indicarsi le ragioni per le quali nel caso concreto, avuto riguardo alla posizione del singolo studente, non possa operare la regola generale, di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo”.
(11) “L’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle spe cifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6 cit., e soltanto se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole” così Consi glio di Stato, sez. VI, 27 agosto 2019, n. 5917. Sulla stessa scia, più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 29 settembre, 2022, n. 8384; nonché TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 agosto 2023, n. 13042.
(12) “La ragionevolezza tecnica del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva deve subire un adattamento in presenza di BES,al fine di assicurare l’inclusione dell’alunno svan taggiato e l’adattamento delle istituzioni scolastiche ai suoi speci f ici bisogni”così Consiglio di Stato, sez. II, 6 aprile 2021, n. 2775.
(13) T.A.R. Piemonte, Sez.III, 2 novembre 2024,n.1115.
(14) A titolo esemplificativo, Cons. Stato, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 293 secondo cui doglianza di tal tenore non possono supportare la domanda di ammissione dello studente, per il tramite dell’an nullamento del verbale di scrutinio, alla classe successiva, ma al più possono essere dirette a far valere pretese risarcitorie per gli eventuali danni subiti: infatti,l’interesse dell’alunno non consiste nell’avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell’indi viduazione del percorso formativo più adeguato, anche nei tempi, per garantire l’apprendimento e il superamento delle difficoltà riscontrate e la mancata o solo parziale attivazione dei corsi di recupero non può elidere la circostanza che lo studente presenti lacune tali da non consentirne l’avanzamento.
(15) Sempre Cons. Stato, sez.VII,14 marzo 2024, n.2493, nel quale viene confermata decisione, prima del Consiglio di classe e poi del giudice di primo grado, circa la non ammissione alla classe successiva di uno studente che presentava gravi lacune addirittura in tre differenti materie.
(16) Cons. Stato, sez.VII, 15 luglio 2024, n. 6370.
(17) Cons. Stato, sez.VII, 8 luglio 2024, n. 6037.
(18) Testualmente si legge in sentenza “il TAR respingeva il ricorso sul rilievo che [...] deriva un giudizio complessivo supportato dall’e sito gravemente negativo in fisica (tre) e in latino (quattro), nel formulare il quale è stata evidenziata una mancanza di continuità e impegno che non ha consentito di colmare le lacune pregresse e che ha indotto il Consiglio di classe a ritenere che la situazione fosse tale da non consentire un proficuo svolgimento del successi vo anno scolastico”.