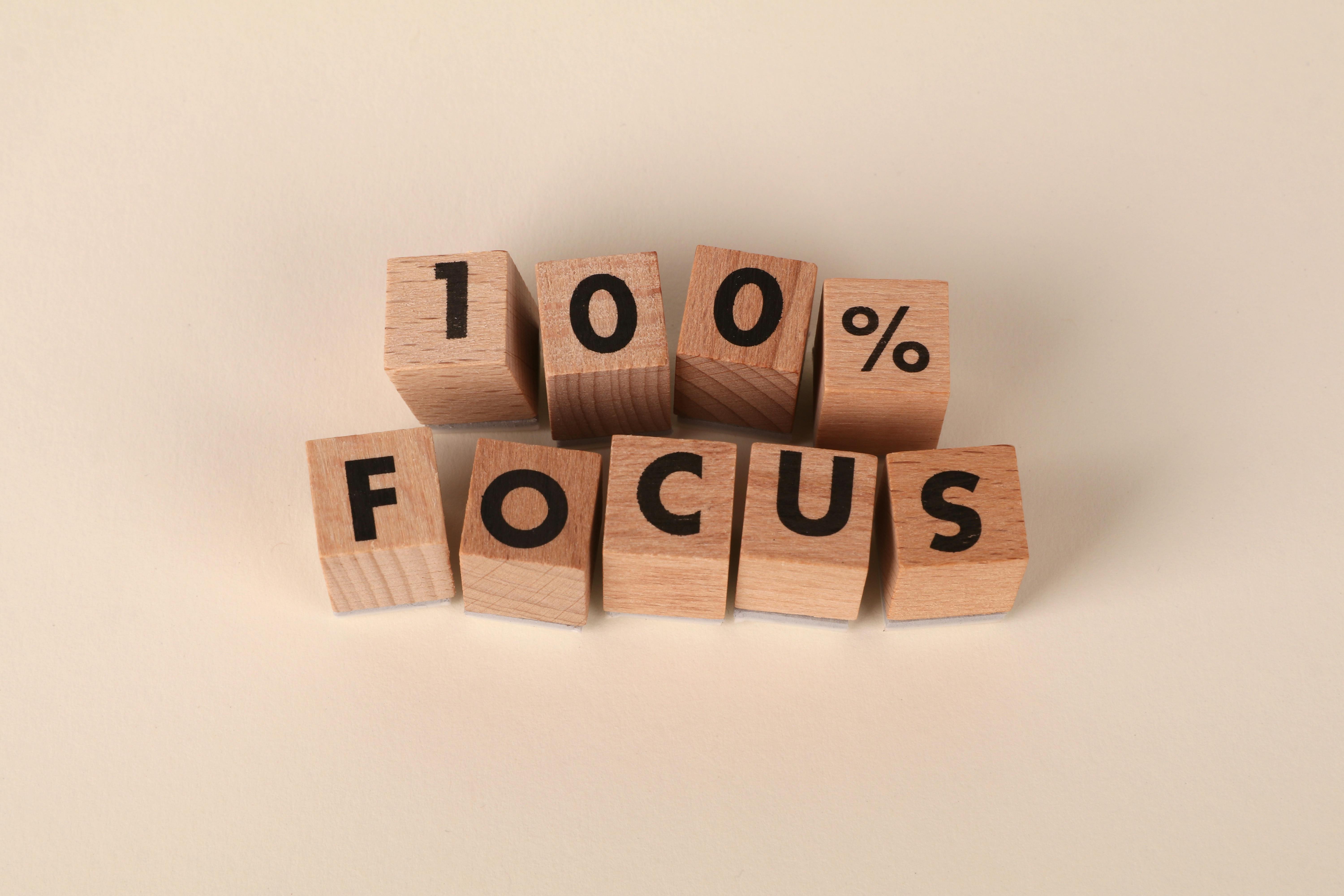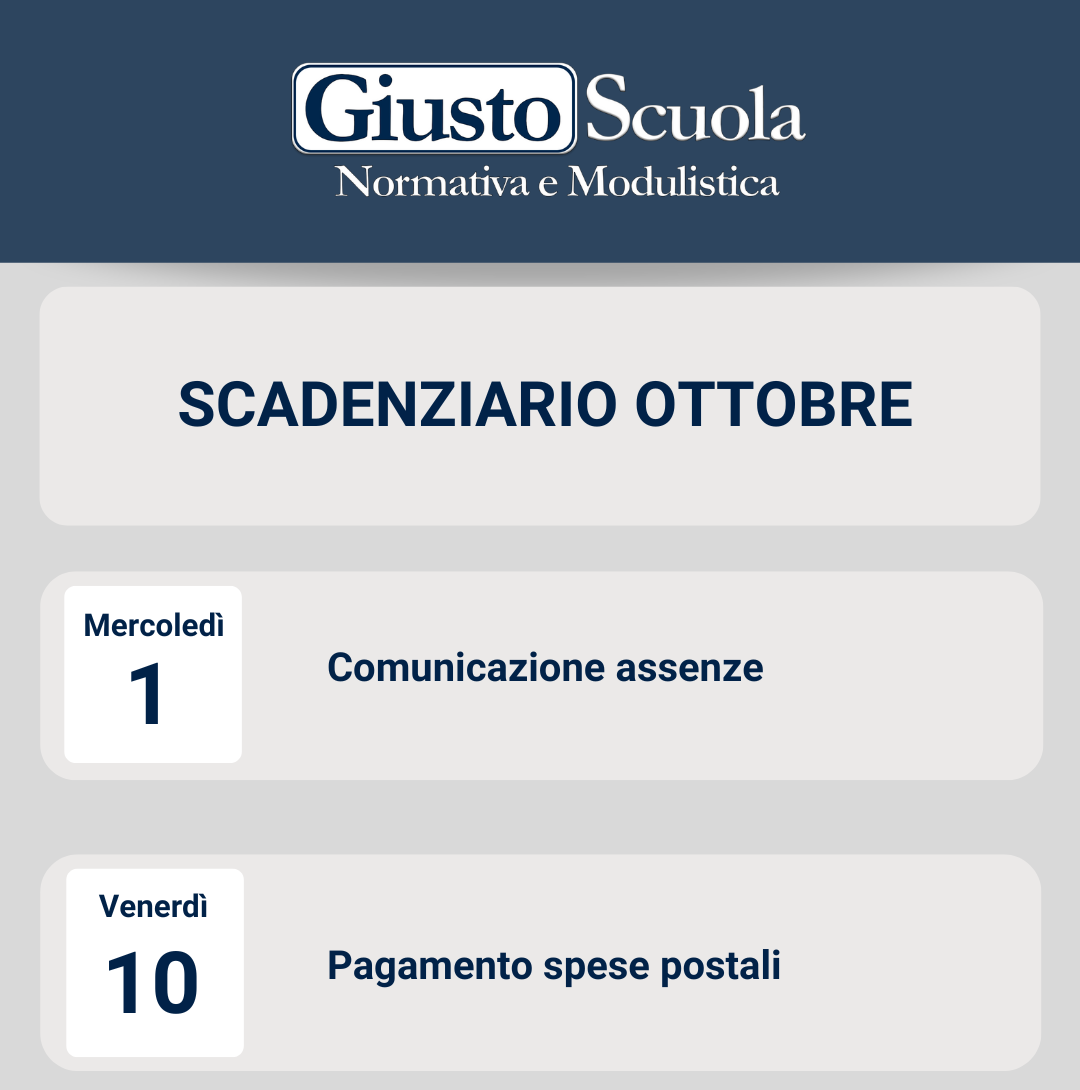La Cassazione civile si è pronunciata il mese scorso in un altro caso che interessa gli illeciti commessi dagli alunni e quindi la disposizione di cui all’art. 2048 del codice civile. In questa sede, tuttavia, la responsabilità dell’educatore riguarda l’istituzione scolastica per i suoi doveri di vigilanza nei confronti degli stessi alunni, e al contempo, parte attorea questa volta sono i genitori dell’alunno che hanno chiesto un risarcimento alla scuola.
L’alunna mentre si trovava nel cortile della scuola per l’attività ricreativa, avvicinatasi ad un cestino di metallo per gettare un oggetto, era stata avvicinata da altro allievo che aveva chiuso il coperchio in metallo con violenza colpendo l’alunna all’altezza dell’occhio, che rimaneva gravemente lesionato.
E’ principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce i cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato 'anomalo', e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Orbene, nell’impugnata sentenza non risultano dalla corte di merito invero spiegate le ragioni per le quali abbia ritenuto 'imprevedibile' la condotta del minore danneggiante, a fortiori in presenza di pregresse condotte dal medesimo mantenute..
Per siffatte ragioni la Cassazione ha cassato l’impugnata sentenza rinviandola alla Corte d’Appello, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Cassazione civile, sez. III, 12 maggio 2020, n. 8811