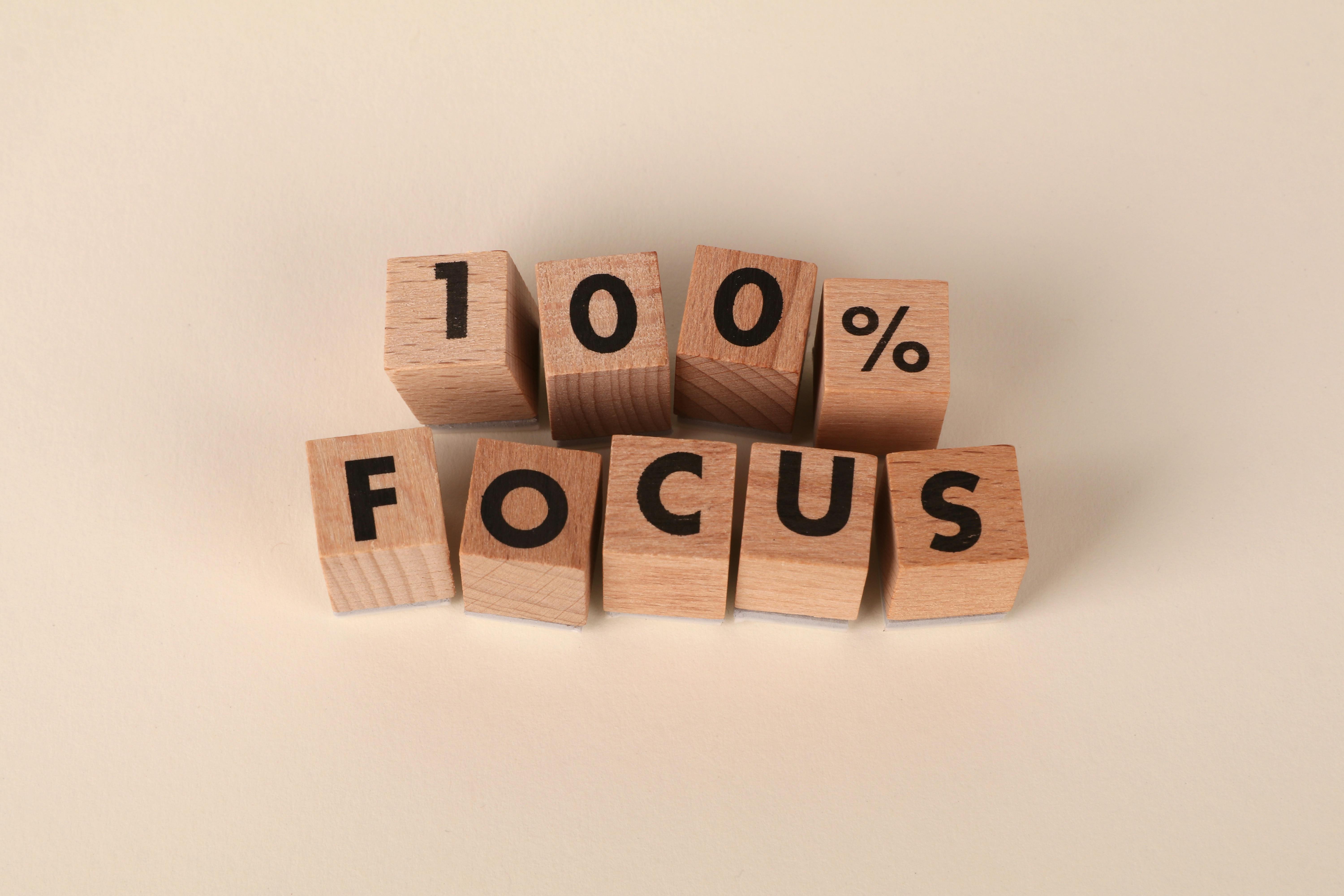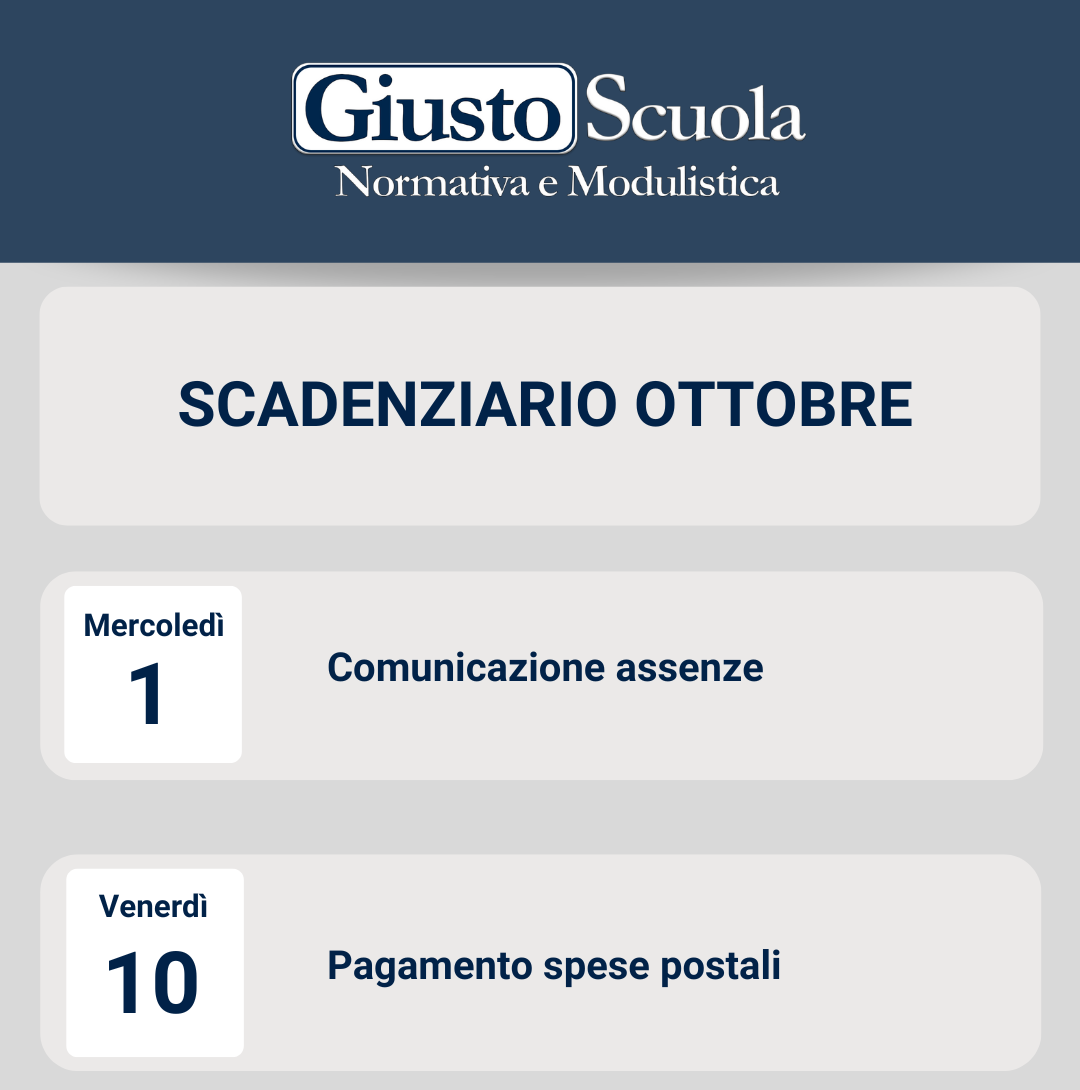Come migliorare il lavoro del collaboratore scolastico
L’attività del Collaboratore Scolastico prevede, dopo una adeguata e costante formazione così come prevista dall’art. 63 del CCNL 2007, un adeguato impegno per svolgere al meglio le funzioni assegnate, con questi obiettivi:
- riuscire ad attuare rapporti collaborativi con i colleghi e con il personale docente per migliorare sempre di più il servizio erogato.
- riconoscere l’importanza della flessibilità lavorativa per poter rispondere efficacemente alle richieste dei cambiamenticontinui.
- avere un atteggiamento disponibile all’innovazione e al miglioramento continuo.
Inclusione, concetto che indica un processo trasformativo al quale sono chiamati tutti i membri della comunità scolastica. L’inclusione, infatti, non è questione che riguarda solo gli insegnanti, perché tutti gli adulti hanno nei confronti delle giovani generazioni precise responsabilità. “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” recita un famoso proverbio africano. Del resto, quando entriamo in una scuola, chi è la prima persona che accoglie alunni e studenti, docenti e dirigente? Il collaboratore scolastico. I processi di insegnamento/apprendimento, infatti, non si esauriscono all’interno dell’aula scolastica, come richiamato dal D.M. 22 agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione - e, successivamente, dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018: la scuola, nella sua totalità, è chiamata a promuovere le competenze di cittadinanza, che trovano nello spirito di collaborazione, nella partecipazione e nella competenza sociale.
Occorre attivare percorsi virtuosi ai quali concorrono anche i collaboratori che, per ciò che concerne la sfera educativa e delle autonomie, possono giocare un ruolo importante. Tale aspetto risulta particolarmente importante soprattutto se si considera la presenza, all’interno delle scuole, di allievi che presentano bisogni e diversità tali da richiedere approcci educativi tra loro eterogenei e diversificati, e che necessitano del supporto di tutti i membri della comunità scolastica.

La formazione del collaboratore scolastico
L’ampliamento delle funzioni ascritte al ruolo del collaboratore richiede pertanto un’accurata riflessione sul tema della formazione. Spesso viene sollevata la questione della scarsa formazione dei collaboratori e l’inadeguatezza delle loro conoscenze e competenze per poter affiancare nella misura più corretta possibile i ragazzi con disabilità.
Le iniziative di formazione non hanno, purtroppo, carattere strutturale; sono episodiche e legate ai finanziamenti e alla propositività di Direttori Amministrativi, responsabili del personale ATA e Dirigenti Scolastici.
Ciò si verifica nonostante ci siano state nel tempo diverse raccomandazioni in tal senso. La nota MIUR nr. 3390/2001 ribadisce, ad esempio, quanto segue: “È necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi all’assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001”. Le Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 esortano i Dirigenti Scolastici a garantire la formazione di tutti gli operatori “per conseguire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili” (parte III punto 3), mentre la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - dispone l’obbligo di formazione in servizio per i collaboratori rispetto alle specifiche competenze “sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica” (c.181). Il successivo D.Lgs. 13 aprile 2017, n.66 - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107 66/2017 - evidenzia che i percorsi formativi in oggetto sono attivati in modo periodico e sistematico.
Invece, nella pratica, nelle scuole normalmente non si invita il personale ATA a partecipare ai GLI (Gruppi di Lavoro Inclusione). Ciò sarebbe opportuno, soprattutto ad inizio anno scolastico, per definire insieme gli ambiti di intervento e il tipo di supporto che tale personale può fornire al Piano Annuale Inclusione (PAI). Nella parte dedicata all’analisi dei punti di forza e di criticità rilevati, dovrebbero essere precisate le azioni intraprese dai collaboratori scolastici. Il loro ruolo, infatti, non deve configurarsi come intervento di emergenza. Conoscere le difficoltà degli alunni consente a tutti gli adulti presenti nella scuola di attuare un intervento specifico e mirato. Un ruolo strategico è assolto dalle figure dirigenziali della scuola (DS e DSGA): queste, attuando i principi di una leadership inclusiva possono contribuire a creare un clima scolastico nel quale ciascuno possa sentirsi valorizzato. In una scuola che aspiri a essere realmente inclusiva è necessario, in altre parole, promuovere occasioni in cui ciascuno possa sentirsi effettivamente partecipe e co-costruttore di un benessere collettivo, anche attraverso la rimozione di quelle che sono le barriere culturali e ideologiche che orientano le politiche e le prassi scolastiche. Il collaboratore potrebbe quindi assumere una funzione di maggior rilievo nel progetto individuale degli allievi con disabilità, ponendosi come un ponte tra la scuola e il territorio, tra il dentro e il fuori, contribuendo ad abbattere una linea di demarcazione che determina barriere di tipo ideologico, culturale e sociale tra chi insegna e chi apprende