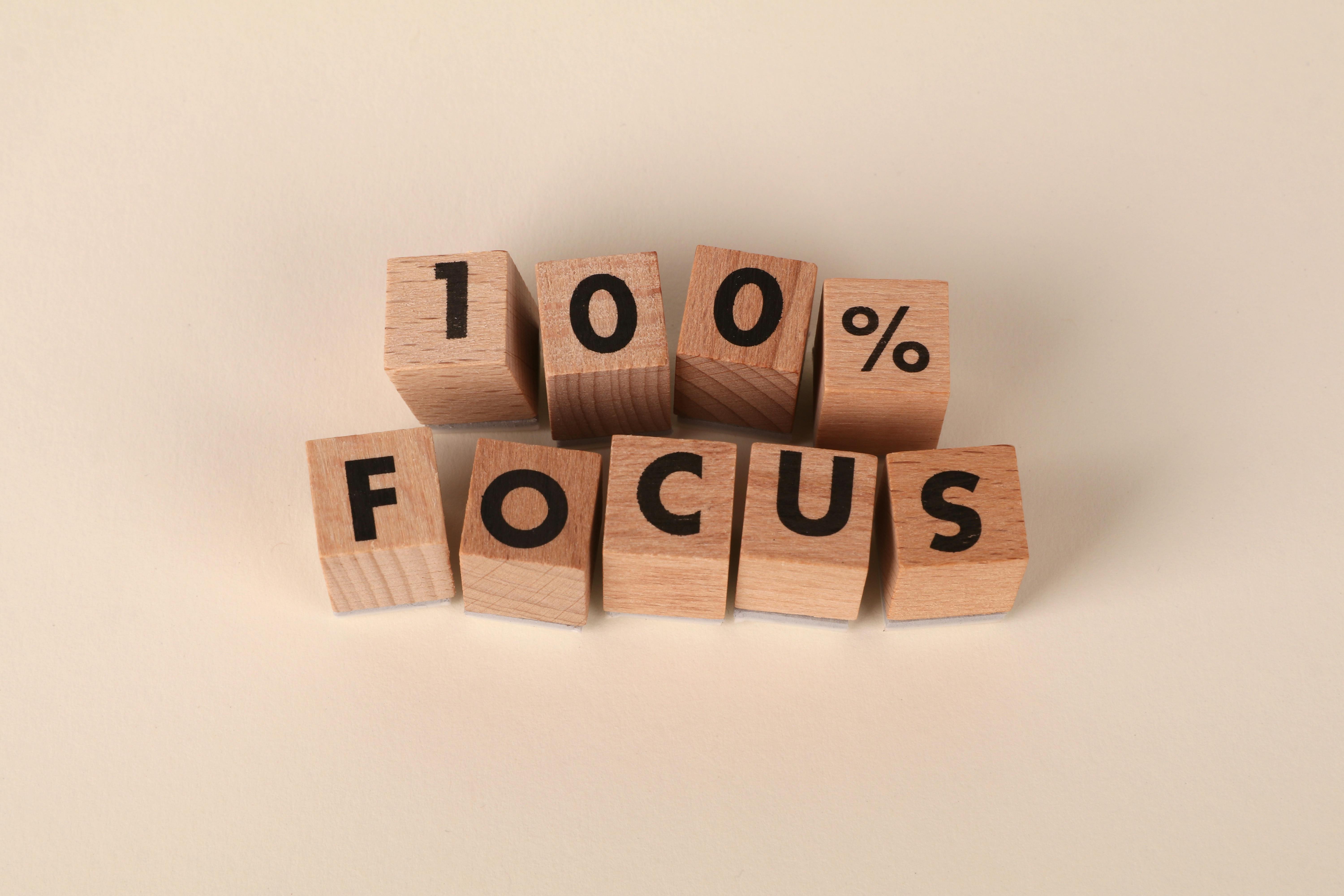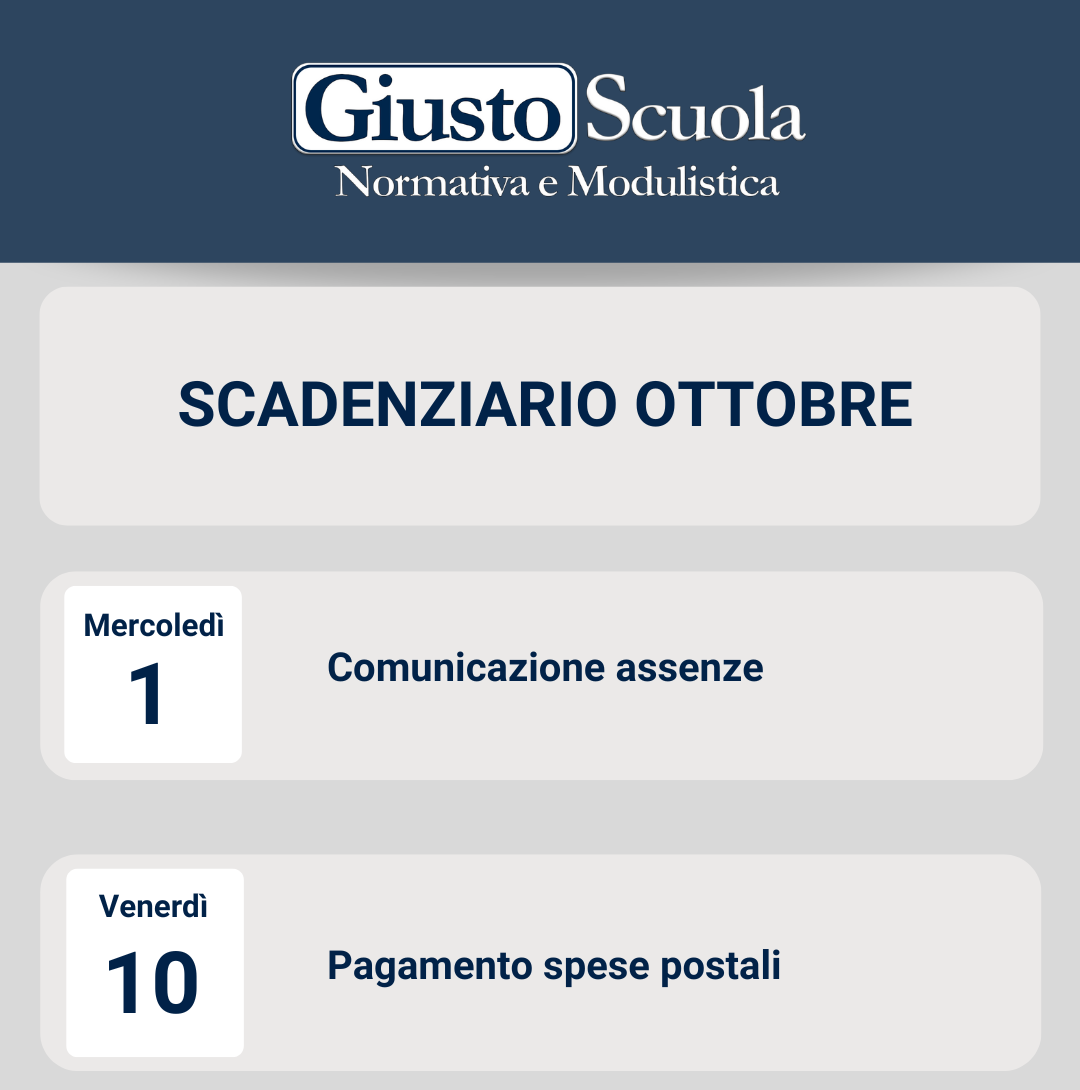1. La responsabilità extracontrattuale o aquiliana
La responsabilità extracontrattuale è la conseguenza che grava sulla persona che, al di fuori di un qualsiasi preesistente rapporto obbligatorio, compie, volontariamente o colpevolmente, azioni o omissioni lesive di interesse altrui e perciò causative di danni ingiusti di natura patrimoniale e non patrimoniale. Il suo fondamento lo troviamo nel già menzionato art. 2043 c.c. che per l’appunto dispone: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Una norma dunque che sancisce la dimensione dell’illecito civile e che consente di desumere i suoi elementi costitutivi: Vale a dire: l’elemento soggettivo (il dolo e la colpa del soggetto); la condotta antigiuridica (l’azione o l’omissione); il nesso di causalità (il legame che interagisce tra l’azione e l’omissione e il danno ingiusto); il danno ingiusto (il pregiudizio arrecato a terzi).
L’elemento soggettivo: possiamo definirlo in estrema sintesi, come lo stato psicologico del soggetto che compie l’azione o l’omissione illegittima e che conseguenzialmente determina l’addebito della responsabilità e del ristoro del danno. Una definizione che in effetti si desume più dall’art. 43 del codice penale, ma che può comunque trovare applicazione in via analogica nel settore civilistico. E infatti, come nell’illecito penale, il comportamento della persona può essere intenzionale e perciò doloso (art. 43 c. 1 c.p.) oppure colposo, per negligenza, impudenza o per violazioni di ordini (art. 43 c. 3 c.p.). Pensiamo ad esempio al proprietario di un fondo che, senza avere alcun vantaggio, e potendo edificare altrove, costruisce un letamaio maleodorante sul confine comune (comportamento doloso).
Pensiamo all’automobilista che, in spregio alle norme del codice della strada e quindi per imprudenza, passa con il semaforo rosso e investe una persona sulle strisce pedonali(comportamento colposo). I successivi articoli (2044, 2045 e 2046 c.c.) prevedono inoltre alcune cause esimenti, che escludono il dolo e la colpa e perciò giustificano alcuni comportamenti che in astratto sono illegittimi. L’art. 2044, in analogia all’art. 52 c.p. esclude infatti la responsabilità extracontrattuale quando il fatto e il danno sono la conseguenza diretta di condotte antigiuridiche, finalizzate a preservare la propria o l’altrui incolumità fisica (legittima difesa).
La giustificazione opera ovviamente a condizione che vi sia una giusta proporzione tra la difesa dell’aggredito e l’offesa subita, ed in più che il pericolo sia attuale e incombente sulla personastessa (art. 2045 c.c.;Cass.sent. n. 18799/2009). Può invocare dunque la legittima difesa, anche in sede civile, il dirigente scolastico che, nel corso di una aggressione fisica di un genitore, reagisce provocandogli a sua volta gravi lesioni.
Costituisce un’esimente anche lo stato di necessità e cioè la condizione della persona che è costretta a salvare se stessa o altri dal pericolo di un danno grave, immediato, inevitabile e da lei non provocato (art. 2045 c.c.). La situazione può riguardare ad esempio l’alpinista che durante l’ascensione rimane appeso all’unica corda disponibile e impedisce agli altri compagni di utilizzarla, provocando loro lesioni gravissime (artt. 2045 c.c. e 54 c.p.). Non è altresì imputabile civilmente, oltre che penalmente, il soggetto che commette il fatto illecito in uno stato di incapacità mentale, a meno che non sia stato egli medesimo a procurarlo. Il riferimento va al minorato psichico, all’alcolizzato cronico, al minore di età. In queste circostanze il risarcimento compete ai soggetti preposti alla loro sorveglianza, salvo che non riescano a provare di avere adottato ogni accurata attenzione per evitare l’evento dannoso (artt. 2047 e 2048 c.c.).
La condotta antigiuridica: si realizza con il compimento di azioni poste in essere dal soggetto in violazione di norme giuridiche che cagionano danni ingiusti. Ma può consistere anche nelle omissioni di eseguire obblighi imposti dal legislatore allo scopo di prevenire danni a persone e a cose. Nel primo caso pensiamo al comportamento imprudente di un automobilista; nel secondo alla omessa vigilanza dell’insegnate sui propri alunni.
Il nesso di causalità: è il rapporto che interagisce tra la condotta antigiuridica realizzata dal colpevole e il danno arrecato. Per cui per poter addebitare ad un soggetto la responsabilità aquiliana è necessario che il danno sia in stretta ed immediata correlazione con il comportamento antigiuridico. Il nesso è invece interrotto quando subentrino soggetti terzi che, con comportamenti altrettanto illeciti, cagioni ulteriori e più gravi pregiudizi alla stessa persona. E’l’ipotesi ad esempio del pedone investito dall’automobilista negligente, il quale muore successivamente in ospedale, non già per le lesioni riportate nel sinistro, bensì per l’imperizia dei medici. Del decesso ne risponderà primariamente la struttura sanitaria, la quale potrà poi rivalersi sul piano economico nei confronti del proprio personale (art. 41 c. 2 e artt. 1223 e 2043 c.c.).
Il danno: si identifica nel pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale che viene arrecato dall’autore di un fatto illecito ad un terzo. Un pregiudizio che, ai fini della sua rilevanza, deve presupporre sia la causalità materiale tra la condotta e l’evento, sia quella giuridica che ne consente l’addebito a chi è chiamato a risponderne ex art. 2043 e segg. c.c. (Cass. sent. n. 4043/2013). In altre parole perché il danno abbia significato, è necessario che si concretizzi il legame diretto tra il comportamento e la lesione (causalità materiale), lo stato di imputabilità della persona che civilmente è tenuta a risponderne e l’inesistenza di qualsiasi esimente (stato di necessità, legittima difesa, minore età) (causalità giuridica). Il danno poi può avere natura patrimoniale e non patrimoniale (o morale): ha natura patrimoniale, se depaupera il patrimonio della persona offesa ed è risarcibile tanto il“danno emergente” e cioè l’effettivo impoverimento della parte lesa, quanto il “lucro cessante” vale a dire gli eventuali mancati guadagni,dovuti alla sua inattività lavorativa (artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c.). Al contrario il danno non patrimoniale riguarda solo le sofferenze morali, biologiche o psicofisiche ed è risarcibile esclusivamente nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.)
2. La responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale consiste essenzialmente nelle conseguenze che scaturiscono nei confronti di chi violi obblighi che derivano da contratti già stipulati, da altri rapporti obbligatori originati da atti illeciti, da atti unilaterali o ancora dalla stessa legge (art. 1373 c.c.). Una definizione che risulta chiara se riferita alle responsabilità nascenti dalle inadempienze contrattuali (art. 1218 c.c.) e dagli obblighi derivanti da fatto illecito (art. 2043 c.c.). Lo è meno se si guarda agli “altri atti idonei a produrre”. In passato qualche autore (Messineo) correttamente sosteneva che il codice ha lasciato all’interprete “l’autorizzazione”a scorgere quali siano questi atti. Atti che oggi,comunque, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono nella “gestione del fatto altrui”(artt. 2028 e 2031 c.c.) e nella ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.).
Più recentemente la dottrina, ma soprattutto la giurisprudenza, ha poi aggiunto a questa categoria taluni comportamenti illegittimi commessi “nell’ambito di contatti sociali qualificati” che per la loro peculiarità, farebbero sorgere veri e propri vincoli giuridici di natura contrattuale e non già extracontrattuale, come invece si riteneva in passato. Per esempio riguarderebbe la responsabilità del Ministero dell’Istruzione e dei docenti per i danni causati dagli alunni a se stessi. La Suprema Corte (Cass. sent. n. 9906/2010; Cass.sent. n. 5067/2010; Cass. Sez. Un. n. 9346/2002) ha ritenuto infatti che con l’ammissione dell’allievo a scuola si instaura “un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e che tra l’insegnante e l’allievo si instaura, per “contatto sociale un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume[…]uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla (propria) persona…”.
Gli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale sono pressoché i medesimi di quelli della responsabilità extracontrattuale (elemento soggettivo; condotta antigiuridica; nesso di causalità tra la condotta e l’evento e il danno), per cui si rinvia al paragrafo precedente.
Si ritiene invece di dover sottolineare alcune differenze esistenti fra le due tipologie di responsabilità.
L’onere della prova: nella responsabilità contrattuale il dolo e la colpa dell’inadempimento è presunto (presunzione relativa). Per cui incombe al debitore (convenuto in giudizio) provare l’impossibilità oggettiva,della mancata esecuzione del debito. Al creditore (attore) per contro è sufficiente documentare la fonte negoziale o legale del proprio diritto (art. 1218 c.c.; Cass. Giuris. Costante sent. n. 9351/2007). Così nel caso di una lesione autoprocuratasi da un alunno a scuola (aderendo alla tesi del “contatto sociale”e quindi ritenendo in questo caso sussistente la responsabilità contrattuale), basterà al giudice adito accertare che il danno si è verificato durante le ore di lezione. Mentre la convenuta amministrazione scolastica è tenuta a dimostrare di aver assunto ogni dovuto accorgimento per evitare l’evento. Nella responsabilità extracontrattuale è invece la parte lesa, e cioè l’attore, a fornire la prova del danno subito e del comportamento doloso o colposo dell’autore dell’ illecito. Pertanto in un incidente stradale è il pedone investito sulle strisce a dover rilevare la condotta colposa del conducente.
Il danno risarcibile: un’altra differenza si coglie nella tipologia dei danni risarcibili. Nella responsabilità contrattuale il risarcimento, qualora l’inadempimento o il ritardo non dipenda dal dolo, ex art. 1225 c.c., è limitato ai soli danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. Quando invece il debitore non adempie alle proprie obbligazioni in modo volontario, è tenuto a ristorare anche i danni imprevedibili (Cass.Giuris. Costante sent. n. 7759/2012). Nella responsabilità extracontrattuale l’art. 2056 c.c. richiama gli artt. 1223 e segg., per cui il risarcimento riguarda sia il danno emergente, sia il lucro cessante.